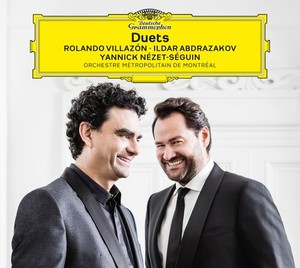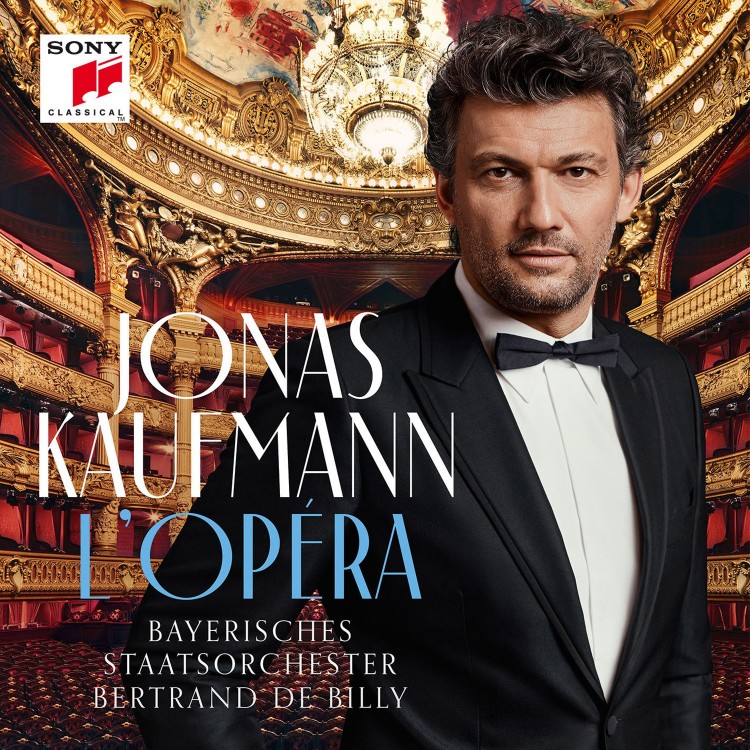Mefistofele
Aggiunto il 03 Luglio, 2016
Muti affronta da par suo questo difficile capolavoro della Scapigliatura, costruito sulle proprie misure e su quelle del protagonista che, per quanto lo concerne, da sempre ne ha fatta un feticcio.
Sam Ramey, cinquantatreenne all’epoca di queste registrazioni e quindi non più propriamente al top delle proprie possibilità, aveva debuttato la parte nel 1975 a 33 anni dopo la prematura scomparsa di Norman Treigle; e, sin dall’inizio, ha imposto la propria personalissima cifra a un personaggio da sempre vittima di cialtronaggini peraltro non estranee alla scrittura di Boito: fine, raffinato, intellettuale, perfettamente scandito. Non ha sicuramente l’ampleur di altri Mefistofele di razza come Nazzareno De Angelis, ma punta in altre direzioni più intriganti, seducendo con la parola perfettamente scandita, in un declamato che forse non sarà perfettamente adeguato al milieu culturale, ma che nondimeno colpisce l’ascoltatore. In perfetta intesa con la splendida direzione di un Muti ispiratissimo, si percepiscono reminiscenze di quel Wagner che purtroppo Ramey non ha mai praticato. Non diversamente da Wotan (e nella mitologia germanica il quasi omonimo Woland è un nome di demonio) l’arma di questo Mefistofele è quella della conoscenza, della consapevolezza, del dominio intellettuale.
Non è un fine dicitore, Mefistofele, almeno sulla carta; ma lo diventa in bocca a Ramey grazie a un lavoro certosino sulla parola, sull’accenno, sulle intenzioni. Ed è grazie a questo lavoro perfetto sulla parola che passano anche in secondo piano alcune note non propriamente cristalline, portato dell’età non più verdissima; ma, nonostante ciò, prova davvero stratosferica, nel contesto di un’immedesimazione tipica di quelli che un cantante normalmente riconosce come i propri “Grandi Ruoli”.
Il Prologo è cantato benissimo, in un botta e risposta di notevole spessore con il coro splendidamente gestito da Roberto Gabbiani e con l’orchestra più sulfurea che magniloquente di Riccardo Muti; davvero un pezzo di grande spessore.
Eccellente anche il Fischio, ripulito da cialtronaggini di basso profilo ma non privo di un tono sarcastico perfetto per la situazione. E anche il Mondo vive delle stesse intenzioni. Il Finale, poi, al netto di un La Scola in discreta (non tremenda) difficoltà, vive sostanzialmente sulle sue spalle.
Grandissimo protagonista, accompagnato da un grandissimo direttore.
Muti, come dicevo, fa infatti un capolavoro. Si percepisce un amore profondo per quest’opera che viene non solo sezionata in tutti i suoi nuclei melodici e più in generale descrittivi, ma anche accompagnata con una dolcezza inusuale per lui. L’accompagnamento di “Lontano, lontano” vive di una tenerezza che riesce a sopravanzare e coprire la mancanza di abbandono dei cantanti, e segnatamente del soprano.
Il Prologo, pur senza arrivare ai vertici visionari di quello di Bernstein – d’altra parte, “visionario” non è un aggettivo che abbineremmo a Muti – è di una bellezza inquietante, grazie anche all’apporto idiomaticissimo dell’orchestra e del coro della Scala che si arrampicano sull’Empireo dialogando da pari a pari con l’intellettuale e sofisticatissimo Ramey.
Notevole comunque anche tutto il resto, compreso anche il Sabba classico con l’episodio di Elena, tanto in uggia al mio amico Elvio Giudici, in cui peraltro la Crider si disimpegna assai meglio che come Margherita.
Già, la Crider. È il vero buco nero di quest’incisione, ed è un peccato. La voce di per se stessa non sarebbe bruttissima: un bell’impasto scuro da lirico un po’ fumoso tipo Leontyne Price; ma le similitudini si fermano lì, perché manca clamorosamente tutto il resto, a cominciare dagli acuti che sono faticosissimi e nemmeno belli. In compenso, in basso deve aprire in modo sguaiato ottenendo effetti paradossali. Il canto è veramente brutto nella parte di Margherita: il suo “L’altra notte in fondo al mare” si colloca proprio in basso in un’ipotetica classifica. Appena meglio nel duetto e solo lievemente meglio come Elena.
Completa il terzetto di protagonisti il povero Vincenzo La Scola, 37 anni all’epoca di questa registrazione e destinato, di lì a non molti anni, a una morte tragica e prematura.
Non si può dire che canti male: all’epoca era una delle certezze che avevamo nell’ambito dei ruoli lirici. Se vogliamo, tuttavia, qualche problema c’è. Per esempio, è un po’ prosaico. Nell’aria che costituì la prova di audizione di Aureliano Pertile al cospetto di Arturo Toscanini, e cioè “Dai campi, dai prati”, si disimpegna bene, con un attento dosaggio del fiato, con un bel legato e con un registro acuto di tutto rispetto. Ma il fraseggio è scolastico: sembra che stia cantando uno stornello, non un’aria di meditazione. Bene, nella sua leggerezza, il “Folletto!” del sabba romantico. Molto bene il “Lontano, lontano”, ma per merito soprattutto di Muti. Decisamente peggio il “Giunto sul passo estremo” e tutto il difficile finale che lo vede piuttosto sottotono, con acuti presi un po’ alla sperindio.
Gavazzi e la Jankovic fanno onesta routine.
Coro invece superlativo, come accennavo sopra.
Pietro Bagnoli