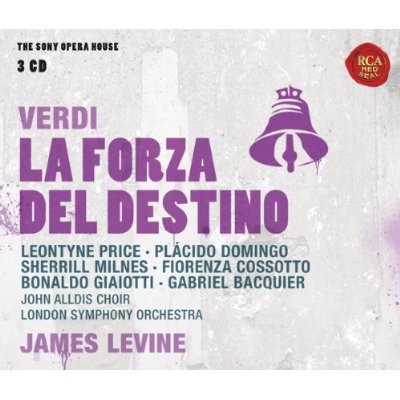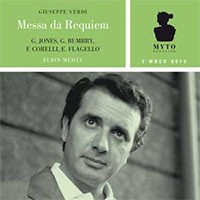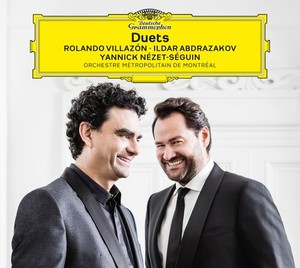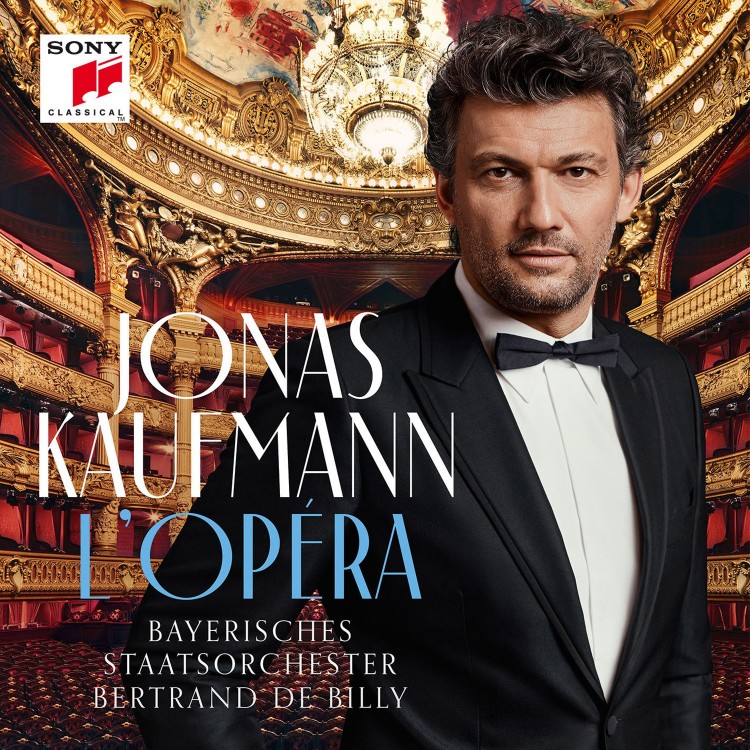Forza del destino
Aggiunto il 18 Giugno, 2016
Quasi sempre di altissima qualità il Verdi di Levine che però, nella Forza, trova un afflato quasi mistico che si sposa in modo ossimorico con la vena cialtronesca con cui pervade tutti gli episodi popolani, gioiosamente sostenuti e cantati. In effetti, credo che l’aspetto che meglio risalta dall’ascolto di questa incisione di quasi 40 anni fa, è l’equilibrio pressoché miracoloso fra tutte le componenti. E tale equilibrio finisce per assorbire in sé e annullare i problemi vocali di alcuni componenti del cast e segnatamente della Primadonna, qui purtroppo molto malconcia.
Il Levine degli Anni Settanta è un musicista completo anche se ha solo 34 anni. Enfant prodige, a quel punto ha già completato la sua formazione con Szell; ha esordito al Met nel 1971 con Tosca e ne è diventato direttore musicale proprio nel 1976, anno di questa registrazione (direttore artistico lo sarà solo dal 1986). È totalmente padrone della materia tecnica e sa come gestirla e utilizzarla a fini espressivi. Solo in Europa – e in particolare in Italia – hanno sempre pensato che fosse un routinier buono per tutti gli usi, ma non è così. Non solo: in Verdi, in particolare, ha sempre avuto un passo estremamente teatrale, frutto proprio di quel “teatro” nel senso più ampio del termine, il Met ovviamente in primis ma non solo, dal cui podio Levine ha diretto migliaia di rappresentazioni, con buon senso, fantasia e ottima gestione delle risorse. Non è insomma la corsa a perdifiato di alcuni direttori che sembrano scambiare il concetto di teatralità con quello di velocità, ma la giusta valorizzazione di ogni singolo momento nell’ottica di raccontare una storia; cosa che Levine fa (quasi) sempre in modo strepitoso, da vero affabulatore.
Prendiamo quest’incisione dell’opera innominabile.
Il preludio scorre con una violenza espressiva ma anche con una precisione ritmica che, dopo, solo Muti saprà eguagliare. Ma ecco che l’attacco degli archi di “Me peregrina e orfana” ha un’allure pensosa e piena di ansia che ben si fonde con la voce franta e angosciata di quel preciso momento storico della cinquantenne Price. E lo sventagliare febbrile sempre dei meravigliosi archi di “Madre pietosa Vergine” è talmente ansimante da tradurre con i soli suoni orchestrali l’angoscia espressa dal canto problematico e fumoso del soprano. Parimenti pensosa la lunga introduzione al grande assolo di Alvaro – un gran bravo Domingo, alle prese con una delle sue migliori prove discografiche – mentre ritorna febbrile l’accompagnamento a “Morir! Tremenda cosa!” in cui il canto di Milnes viene accompagnato in modo a dir poco scintillante.
Non meno esaltanti gli episodi in cui hanno il sopravvento la folla, Melitone e Preziosilla, la cui importanza drammaturgica – e non di solo colore – è per Levine fondamentale, esattamente come Fantine, Eponine, i Thènardier e Gavroche per Hugo. I Miserabili di Verdi ricevono da Levine una dignità pari almeno a quella dei protagonisti e delle loro intricatissime vicissitudini.
Quindi, direzione storica ed estremamente “filologica” nel senso di collocarsi alle radici più profonde della “verdianità”: nemmeno Muti si sarebbe spinto così lontano nell’esegesi di questo capolavoro.
A tanta direzione non corrisponde, però, un canto di pari levatura, soprattutto nel lato femminile.
Di Leontyne Price ho già parzialmente detto: a quasi cinquant’anni sostanzialmente non è più in grado di sostenere le ampie campate di Leonora. Nella parte medio-alta funziona ancora abbastanza bene, ma alle due estremità del pentagramma è un disastro. In basso è un insieme di suoni brutti, gutturali, rauchi, dalle risonanza mascoline; in alto fa veramente fatica e mancano quasi completamente le meravigliose smorzature per cui era famosissima. Chi voglia sentire cosa era capace di fare in questa parte, si vada a sentire l’incisione di Schippers del 1964, quindi di oltre 13 anni prima: lì la Price era talmente onnipotente da porsi sul piedistallo insieme alle regine di questa parte, vale a dire la Tebaldi (per fatti squisitamente vocali) e la Gencer (per fatti non solo vocali). Qui purtroppo c’è solo la consapevolezza di un personaggio che sente suo come pochissimi altri – fra i verdiani, forse solo Aida – e in cui ha la possibilità di infondere tutte le reminiscenze ancestrali che, quando voleva, sapeva far risuonare.
Di voce ne avrebbe invece in abbondanza Fiorenza Cossotto che, però, come al solito naviga alla superficie oscillando fra risonanze poitrinées e acuti taglienti.
Meglio il versante maschile.
Domingo, come detto, nonostante le ben note difficoltà negli acuti, canta benissimo, con consapevolezza e dolente umanità. Mostra oltre a tutto un’intesa di primissimo ordine con il baritono, per cui i loro duetti sono momenti elettrizzanti, di teatro allo stato puro. Ottimo davvero l’assolo dell’inizio del terzo atto, peraltro splendidamente accompagnato da Levine.
Splendido anche Sherrill Milnes che dipinge un Don Carlo di Vargas se vogliamo molto convenzionale, ma lo fa con voce stratosferica e con un’arroganza basata su acuti dal nitore insolente. Anche nel suo caso eccellente assolo del terzo atto
Notevole anche Bonaldo Giaiotti, di casa al Metropolitan in quegli anni: il suo Padre Guardiano è molto confidenziale e proprio ben cantato, con notevole comprensione del personaggio.
Ottimo anche Bacquier nel disegnare un personaggio profondamente cattivo e lontano dalle cialtronate cui sembra solitamente destinato.
Così così i comprimari, che abbassano discretamente il livello: Sénéchal come Trabuco dice la sua, ma Moll è un Marchese di Calatrava assolutamente inascoltabile, e fra questi due estremi si muovono tutti gli altri.
Coro di notevole efficienza.
Pietro Bagnoli