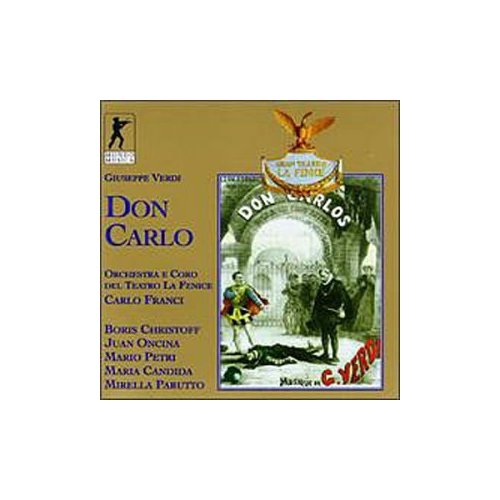Don Carlo
Aggiunto il 19 Agosto, 2006
Amiamo molto le regie di Willy Decker, che sa andare al cuore del problema come ben pochi altri registi d’opera di oggi. Quello che non amiamo, invece, di Decker è la sua tendenza a sottolineare, ad essere pesantemente didascalico, quando invece potrebbe accontentarsi di quello che ha già ottenuto con gli elementi che mette in campo.
Nella presente edizione, Decker sceglie un’ambientazione opprimente: il famedio dell’Escurial, con gli ossari dei sovrani in evidenza su una murata semicircolare che occupa il palcoscenico ad anfiteatro. Le spoglie dei sovrani contemplano le azioni degli uomini, ponendosi quasi come muti giudici con una presenza che non è mai svelata, ma che è sempre evidente.
Tutti i protagonisti agiscono in questo contesto, che scompare solo nella scena del giardino, allorquando una volta stellata scende dal cielo a coprire le tombe; ma nemmeno questo cielo è rassicurante, e finisce per schiacciare anch’esso le vicende degli uomini.
Chi ne fa le spese è principalmente lo sfortunato Don Carlo, cui Rolando Villazon presta la propria maschera mobilissima: il protagonista è schiacciato dalle presenze degli augusti predecessori e da una volontà ultraterrena che non comprende, prima ancora che dalle vicende che deve subire per la ragion di Stato. Gli altri protagonisti, vuoi perché non così coinvolti, vuoi perché non così bravi nel rendere le psicologie dei propri protagonisti, sono per così dire più contemplativi: qui non ci sono dubbi di sorta, Don Carlo è il vero e indiscusso protagonista, quello che verrà progressivamente schiacciato dal peso degli antenati, dall’angoscia delle vicende che non capisce e, non ultimo, dal peso di una responsabilità di cui non riesce a farsi carico; concluderà la propria vicenda suicidandosi mentre sente la voce del Frate che lo chiama, quasi a voler raggiungere l’unica entità – ultraterrena – che gli regala una parola di confronto.
E fin qui tutto bene: si fosse limitato a questi aspetti, Decker avrebbe montato uno spettacolo perfetto. Ciò che invece disturba è la comparsa di elementi che potremmo definire “sottolineativi”, un’iperbole pleonastica che non fa altro che gravare in modo grottesco su un’azione che già di per se stessa non è semplice. Questa tendenza al didascalismo è particolaremente fastidiosa allorquando, per esempio, compaiono i piedi di un crocifisso che schiacciano ulteriormente il povero Don Carlo; oppure quando, nel monologo del terzo atto, Filippo II canta appoggiato alla propria bara con il proprio loculo aperto e pronto, per così dire, all’uso. E a fronte di questo carico di briscola, la mente dello spettatore (italiano) va con fastidiosa inevitabilità a Libero, il fratello di Levante che nel “Ciclone” di Pieraccioni dormiva proprio dentro una bara dopo aver riempito tele su tele con su scritto: “Dio c’è?”.
E che dire poi dei costumi?
I personaggi buoni e sfigati (Don Carlo, Elisabetta e Posa) sono vestiti di bianco.
I personaggi cattivi (Filippo e Eboli) sono vestiti di nero.
E, per buona misura, il Grande Inquisitore è vestito di rosso sangue.
Peccato perché, a parte le varie facezie, lo spettacolo complessivamente c’è e basterebbe eliminare queste inutili sottolineature che non fanno altro che impinguare un’azione disposta già in modo intelligente che non avrebbe bisogno di inutili pleonasmi. L’Autodafé, per esempio, non ha la stessa efficacia essenziale che aveva con Bondy nello spettacolo dello Chatelet, ma l’irruzione del popolo e dei condannati dal fondo ha una potenza visionaria non indifferente, grazie anche all’ottimo design delle luci.
La versione scelta è quella di Milano in 4 atti. Ora, si potrebbe stare a discutere per giorni sul fatto che manchi tutta la bella musica dell’atto di Fontainbleau, ma non si può negare a questa versione una maggior speditezza e, addirittura, una maggior efficacia drammatica. La versione in 4 atti sottintende tutto ciò che di bello c’era stato fra Don Carlo ed Elisabetta risparmiandoci un innamoramento troppo rapido e, in definitiva, alquanto incongruo. Nella versione in 4 atti non c’è mai felicità fra i protagonisti, ma questa decisamente non è un’opera per anime ottimiste. Ciò di cui invece c’è complessivamente da dolersi è che la versione in 4 atti sia gravata dalla terribile traduzione italiana di Achille De Lauzières, che è invecchiata molto male soprattutto in certi incisi (“Ed ora si sospetta l’onor di Elisabetta”, e tutto quello che segue), ma che soprattutto non ha mai un grammo della poesia del testo francese infinitamente più pregnante.
Chailly dirige con bel piglio, anche se non con eccessiva fantasia: la sua direzione punta decisamente al pratico permettendo un corretto dipanarsi dell’azione e una narrazione agile e priva di fronzoli. Non è poco, in un’operona del genere; ma con la particolare impostazione registica e con il protagonista a sua disposizione, forse si poteva osare qualche cosa di diverso.
Lo spettacolo si avvale della presenza carismatica di Villazon, il quale appare per l’occasione in splendida forma vocale, anche se non manca qualche attacco sporco, qualche colpo di glottide soverchio e una certa fastidiosa tendenza a domingheggiare or quinci or quindi. Peraltro l’immedesimazione col personaggio è talmente piena da risultare persino inquietante: in questo momento è indiscutibilmente il Don Carlo per definizione, quello che meglio di chiunque altro riesce a rendere credibili i tormenti e i trasporti dell’Infante, in un montare della tensione che punta tutto sulla psicoticità che si evidenzia nella mobilità degli sguardi allucinati, nell’arrancare per il palcoscenico sotto il peso opprimente del famedio. Quello di Don Carlo è ruolo complessivamente abbastanza centralizzante, ma non mancano puntate all’acuto sul passaggio; anche qui Villazon ha modo di imporsi senza particolari problemi. Splendida prova veramente.
Del pari ottima la prestazione di Dwayne Croft, uno dei migliori Posa che abbiamo mai sentito. Il timbro pastoso è da baritono grand seigneur; la vocalizzazione è di altissimo profilo; l’interprete è sereno, misurato, mai sopra le righe, ma non esente da incisività nei momenti che lo richiedono. E il suo finale è toccante e memorabile. Una prestazione maiuscola.
Non così esaltante dal punto di vista vocale, tuttavia Lloyd si fa ancora apprezzare per quel grandissimo professionista che è sempre stato, proponendo un Filippo torvo, autoritario, mai incline alla comprensione umana, violentemente sospettoso. Un Filippo ancora importante.
Fastidiosamente sopra le righe Ryhänen, un inquisitore di voce grande e ben emessa, ma un personaggio erribilmente convenzionale: a quando un Inquisitore freddo, sorridente, dimesso e quasi distaccato, che faccia vivere in modo gelido ed insinuante il potere della Chiesa militante?
Quanto alle donne, siamo rimasti piuttosto delusi.
Ci aspettavamo molto di più dalla Roocroft, che dipinge un personaggio algido e distaccato, ma che non ha tutte le note della parte. Le sue arie sono entrambe tirate via e prive di una vera partecipazione emotiva; partecipazione che, invece, traspare dai duetti con Don Carlo, ma forse anche per effetto della presenza di Villazon.
Quanto alla Urmana, è sempre più un mistero. Non è decisamente più un mezzosoprano, ma come soprano è piuttosto corto. Tutto sommato è una specie di Falcon, il che potrebbe andar anche bene per Eboli, ma non ci sembra interessante per i grandi personaggi sopranili che sta affrontando o che ha in animo di debuttare. L’interprete si sforza di essere sempre varia ed interessante, ma si ha la sensazione che cerchi sempre la sottolineatura, il colpo ad effetto; in altre parole, che manchi di spontaneità anche per la difficoltà a controllare una fonazione che non ha più un alveo ben preciso in cui incanalarsi