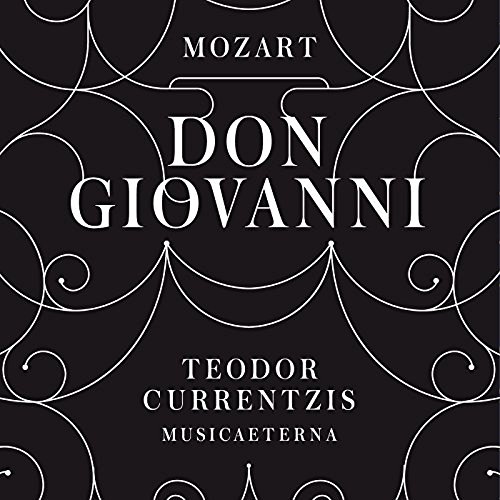GUGLIELMO RATCLIFF
Aggiunto il 11 Aprile, 2017
Il livornese Pietro Mascagni (1863-1945) iniziò a studiare all’età di tredici anni con il compositore e teorico Alfredo Soffredini, appena rientrato in Toscana dopo gli studi musicali a Milano. Fin da subitò Mascagni mostrò grande talento compositivo, che si rivelano fin dalle primissime prove tra il 1878 e 1882, tra cui la romanza “Duolo eterno”, composta in memoria della madre prematuramente scomparsa, oppure l’idillio “Alla filanda” o ancora la composizione “Alla gioia”. Probabilmente proprio la positiva ricezione di quest’ultima convinse il padre Domenico Mascagni a permettere al figlio di trasferirsi a Milano per proseguire gli studi al conservatorio cittadino che era guidato da Amilcare Ponchielli.
A Milano in quegli anni, gli ambienti musicali e culturali in genere erano in fortissimo fermento, basti pensare che Mascagni inizialmente condivise una stanza con un altro toscano divenuto poi illustre, Giacomo Puccini, di cinque anni più grande di lui. Il maggiore motivo di interesse però nella cultura milanese coeva era il cosidetto “Salotto Maffei”. Nel marzo 1832 il poeta Andrea Maffei (1798-1885) sposò la diciottenne Clara Spinelli, figlia del conte Giovan Battista. Due anni più tardi, nel 1834, per attenuare la solitudine della moglie, affranta per la morte a soli nove mesi dell'unica figlia, il letterato cominciò ad aprire la propria casa agli scrittori e agli artisti a lui più legati. Nacque così il “Salotto Maffei” che, in breve tempo, grazie alla fama e all'ampia gamma di relazioni di Andrea e all'amabile accoglienza giovanissima Clara, divenne un imprescindibile punto d'incontro di aristocratici, intellettuali ed artisti, sia di Milano, sia della penisola che provenienti dall'estero. E Pietro Mascagni ebbe proprio nel contatto con il letterato una delle maggiori ispirazioni della propria vita.
Maffei aveva studiato peraltro anche in Alto Adige e a Monaco di Baviera da uno zio e divenne con il tempo uno dei più apprezzati traduttori dal tedesco all’italiano, facendosi promotore della grande letteratura romantica tedesca nel Bel Paese allora avvolto dalle fiamme risorgimentali. Nei primi anni di conservatorio, Mascagni ebbe modo di leggere la ballata drammatica “Wilhelm Ratcliff” (1822) di Heine nella traduzione di Andrea Maffei e rimase completamente folgorato da quella romantica tragedia piena di fantasmi, di sangue, di amori e vendette immersi in un brumoso paesaggio scozzese.
Nel corso di una intervista raccolta dall’editore Salvatore De Carlo nel volume Mascagni parla. Appunti per le memorie di un grande musicista, Mascagni afferma che il soggetto del “Guglielmo Ratcliff” fu davvero la sua prima folgorazione operistica: «Il Ratcliff è stato sempre la mia grande passione, l’opera grande, come la chiamavo all’epoca del Conservatorio. Fu in Conservatorio che mi capitò di leggere in un opuscoletto la traduzione del Guglielmo Ratcliff di Heine. Il traduttore era Maffei ed i versi mi sembravano tanto belli che li declamavo di notte, passeggiando su e giù per la camera. Di quei versi me ne innamorai insomma, e non sognavo altro che l’osteria di Tom e la passione fantastica di Guglielmo, quella passione che io ho cercato di trasfondere nel “Sogno”. Il Ratcliff fu dunque veramente la mia prima opera, il mio primo figlio, proprio il figlio dell’amore».
Da questo passaggio biografico possiamo trarne alcune osservazioni. Innanzitutto vi è da dire che Mascagni decise di adoperare come libretto per la propria opera direttamente la traduzione di Maffei della ballata di Heine senza alcun rifacimento o accorgimento. È decisamente una scelta quanto mai delicata, in quanto la tragedia heiniana è stata predisposta per la recitazione e non per la musica e non si presta affatto a strutture tipiche del teatro lirico. Questo costringe Mascagni a far procedere parallelamente testo poetico e invenzione musicale, dando priorità alle idee melodiche, che sembrano muoversi secondo una logica piuttosto strumentale che vocale: si veda per esempio il grande racconto di Margherita al quarto atto che fa le veci del preludio stesso, nel quale vengono inglobati, praticamente a forza, i troppi versi della tragedia. La volontà di Mascagni sembra quindi essere piuttosto quella di pensare ogni singolo atto come un distinto poema sinfonico con voci.
La genesi stessa dell’opera è poi abbastanza travagliata. Appena Mascagni rimase così infatuato dalla ballata heiniana, iniziò a scrivere velocemente alcuni brani (probabilmente intorno al 1882), tra cui l’intermezzo del terzo atto denominato “Sogno”. Il lavoro poi si interrompe, a seguito dell’abbandono del Conservatorio a causa di una mancata esecuzione proprio del “Sogno”. Abbiamo poi tracce nel luglio 1885, in cui pare vengano completati l’introduzione e tutto il quarto atto. Il 4 aprile 1886 il musicista parla della romanza di Guglielmo (“120 versi sciolti”) al secondo atto; in agosto lavora al lungo racconto di MacGregor del primo atto. Arriviamo così al 1889, anno in cui “Guglielmo Ratcliff” viene eseguito privatamente. Mascagni però lo ripone nel cassetto dedicandosi alla “Cavalleria Rusticana”, forse seguendo il consiglio di Puccini il quale profetizzò per lui che il Ratcliff non avrebbe potuto essere il suo primo lavoro proposto al pubblico. Quindi, forte del successo di “Cavalleria” riprende il “Ratcliff”, dedicandosi fra il marzo 1893 e il gennaio 1894 alla elaborazione definitiva della partitura.
“Guglielmo Ratcliff” dunque vive di più di una stagione della cultura milanese. Era nato sotto la stella della scapigliatura, in un clima di forte interesse per il mondo nordeuropeo sotto cui videro la luce anche “Mefistofele” di Boito (1868), le opere di Alfredo Catalani e “Le Villi” (1884) del giovane. Nel frattempo però Milano aveva anche vissuto anche l’esperienza verista. Pertanto quando il “Ratcliff” viene finalmente presentato al pubblico si mostrò immediatamente come opera diversa rispetto al genere ormai di moda, sia per la scelta di personaggi e di suggestioni fantastiche, sia per il clima cupo e tetro, così lontani dalle piccole storie sentimentali dell’”Amico Fritz” o di altre opere coeve. La vicenda, infatti, è incentrata sul destino di Guglielmo quale eroe maledetto, che uccide tutti i pretendenti alla mano dell’innamorata Maria, la quale è nuovamente promessa sposa al conte Douglas. Questo antefatto occupa il primo atto, ambientato nel castello di MacGregor padre di Maria, alla presenza proprio della figlia, della nutrice (la folle Margherita) e del promesso sposo (Douglas). Guglielmo, nel secondo atto, in una taverna, racconta all’amico Lesley di amare da tempo Maria e di essere indotto a quei delitti dalla visione spettrale di una coppia di infelici innamorati, nei quali egli ha identificato sé e Maria. Al Negro Sasso, dove sono stati uccisi gli altri pretendenti, Guglielmo sfida a duello anche Douglas (terzo atto), ma viene da lui risparmiato. L’ultimo atto svela il misterioso legame tra Maria e Ratcliff: i loro genitori morti, non avendo potuto coronare il loro sogno d’amore, cercano vendetta attraverso i delitti di Guglielmo il quale, in un raptus di follia, uccide Maria e si suicida: i fantasmi possono così ricongiungersi, pacificati sotto lo sguardo di Margherita.
Una vicenda misteriosa che, anche per il goticheggiante colore ambientale, potrebbe appunto apparire diametralmente opposta alle calde tinte mediterranee e alle passioni esplosive di “Cavalleria rusticana” ma in realtà anche con quest’opera Mascagni dette prova di non volersi conformare al modello borghese e alle sue ipocrisie. “Gugliemo Ratcliff” però va oltre, realizzando volontà stilistiche e compositive totalmente nuove. Seguendo l’insegnamento di Boito, Mascagni da ampia visibilità e importanza all’elemento sinfonico, che si espande sin dalla nenia di Margherita nel primo atto (se vogliamo questo brano fa un po’ da contraltare alla serenata di Turiddu) oppure nell’intermezzo del quarto atto e, ovviamente, nel grandissimo intermezzo “Sogno”, unica pagina nota dell’opera. “Guglielmo Ratcliff” però pone un definitivo e non-nostalgico rifiuto alla netta e rigida divisione schematica tipica dell’opera italiana, a parte i due idilli di Margherita (“Apri piccina”) e di Willie (“Padre nostro”), portando a compimento l’influenza wagneriana in Italia. Lo studio di Mascagni poi sulla cosidetta “parola intonata”, ovvero l’adozione diretta di una tragedia piuttosto che la conversione in libretto, è l’aspetto più prettamente sperimentale dell’opera, forse motivo della sua travagliata genesi.
Seguendo la struttura drammatica di Heine, Mascagni pone insistenza su quattro grandi monologhi, uno per ciascun atto in cui il compositore crea dei vertici all’interno degli atti stessi dando spazio ad ampie oasi liriche. Il primo (“Già corre ii sesto anno”) è cantato da MacGregor e presenta l’antefatto; i due monologhi centrali (“Quando fanciullo ancora” e “Ombra esecrata”) sono entrambi destinati a Ratcliff mentre nell’ultimo (“E bella, bella era tua madre”) la nutrice Margherita anticipa la tragedia finale. Queste lunghe pagine solistiche e le generali difficoltà di allestimento emersero fin dalla prima rapprentazione alla Scala il 16 febbraio 1895, pure di gran successo, ma che preoccupò non poco Mascagni. Francesco Tamagno, che sarà il grande Otello verdiano, rifiutò la parte a causa dell’eccessiva lungaggine del ruolo che venne quindi accettato da Giovan Battista de Negri che, volere della sorte, sarà il più famoso moro di Venezia dopo Tamagno. Anche il ruolo di Margherita pose non pochi problemi. Infatti Mascagni trovò nella francese Renée Vidal un’ottima interprete ma purtroppo si ammalò alla vigilia della prima e venne sostituita velocemente da Della Rogers, obbligando però il compositore a eliminare il grande monologo del quarto atto.
Dopo la prima “Guglielmo Ratcliff” scomparve dal cartellone scaligero e praticamente da tutti quelli dei teatri italiani. Il beneamato Wexford Oper Festival, giunto nel 2015 alla sua 64esima edizione con lo scopo di promuovere opere italiane neglette sia di belcanto sia del tardo Ottocento, ha deciso di mettere nuovamente in scena quest’opera così affascinante, radunando per l’occasione un bel cast di giovani italiani. Francesco Cilluffo è direttore che è per la seconda volta alle prese con una partitura di tardo Ottocento (interessante la precedente produzione marchigiana de “L’Arlesiana”di Cilea e tornerà a Wexford per “Risurrezione” di Franco Alfano) e Fabio Ceresa è un regista con idee semplici, mai banali, e in grado di realizzarle sempre con perizia tecnica e attenzione al dettaglio. I cantanti è vero che non sono delle star e hanno raramente calcato i grandi palcoscenici, ma hanno l’umiltà di lavorare al servizio del teatro adoperandosi spesso in ruoli di opere poco note, poco rappresentate o neglette spesso con buoni risultati.
Francesco Cilluffo dirige con grande attenzione drammatica. Infatti la tentazione sarebbe quella di concepire le parti sinfoniche e narrative che compongono ogni singolo atto come entità a se stanti. Cilluffo invece le concerta dando un corretto senso di unità; stupenda la gestione del tema ricorrente del sogno, che viene sempre riproposta sotto una nuova luce a ciascuna sua ripresa. L’intermezzo del “Sogno” è eseguito con giusto piglio, senza mai cadere in un inutile sentimentalismo. Le dinamiche poi son appropriate, senza mai invadere il canto. L’orchestra non risponde sempre al meglio ed è distratta in più punti.
Due ruoli dell’opera sono massacranti: quello del protagonista e quello della nutrice Margherita. Il siciliano Angelo Villari è Guglielmo Ratcliff. Villari ha voce principalmente di sfogo, molto aperta e dall’ampia sonorità, di timbro graffiante, generoso e incisivo, risolve tutto sommato bene i due lunghissimi monologhi che sfociano assai spesso nella tessitura più acuta. Villari ha dei cedimenti in questi salti nelle zone alte così come anche nel finale mostra segni di indubbia stanchezza. A mio avviso poi Villari crea solo parzialmente il personaggio, non curando molto le dinamiche ma sforzandosi solo di cantare abbastanza forte. Margherita è invece impersonata da Annunziata Vestri. Il timbro è assai gradevole, molto brunito nel registro medio e basso ma anche il ruolo di Margherita ha parecchie difficoltà e tende insidie a un mezzosoprano e la Vestri incappa in quale nota sgraziata nel monologo del quarto atto. Però va detto che la Vestri crea un bellissimo e veritiero personaggio di donna lacerata nell’animo, fin dalle prime battute di “Ho ucciso la mia cara” passando poi per le visioni della spada insanguinata.
Mariangela Sicilia interpreta Maria. Anche in questo caso abbiamo una voce davvero molto bella per timbro e colori ricercati, però la Sicilia è più attenta e va con facilità all’acuto senza troppo schiacciare le note. È un ruolo abbastanza defilato vocalmente, che però ha il proprio apice nel grande duetto finale e il soprano campano da prova di grande maturità ed aderenza stilistica. Ottima prova anche di Gianluca Buratto, basso dalla voce calda e pastosa, avvezzo anche al registro acuto.
Iniziano poi le vere note dolenti della registrazione: il conte Douglad di David Stout è tanto arrogante quanto sgraziato vocalmente, così come il nasaleggiante Lesley di Alex Tsilogiannis. Voci brutte e dizione italiana al limite dell’interpretabile per tutte le voci di fianco, mentre Sarah Richmond interpreta il giovane Willie con credibilità e proprietà di fraseggio.
Il coro ha un bell’impasto sonoro, precisione e attenzione drammaturgica ma anche in questo caso la dizione italiana è pessima.
Il cofanetto cartonato include anche un opuscolo solo in inglese con tracce, alcune foto, note dell’opera e libretto integrale. Purtroppo il fasciolo include anche parecchi errori di ortografia, errori di battitura, nonchè parecchie parti mancanti del libretto.
È una registrazione dunque senz’altro interessante prima di tutto per conoscere un bel titolo, che però va detto soffre non poco di parecchie debolezze drammaturgiche. Per metterlo in piedi ci vuole un direttore volenteroso che capace: Cilluffo lo è, specie con queste partiture, ma ci vorrebbe anche un’orchestra allo stesso livello. Interessantissimo il giovane quartetto vocale e tutto italiano Villari-Vestri-Buratto-Sicilia; le pecche dei singoli sono trascurabili perchè alcuni ruoli di quest’opera sono davvero mostruosi e bisogna guardare invece all’esecuzione nel suo complesso che appare comunque fresca e generosa. Forse se eseguita in un teatro italiano avrebbe avuto un coro e comprimari più all’altezza; vediamo se per caso Chailly e il Teatro alla Scala avranno voglia di imbattersi in quest’impresa...
Fabrizio Meraviglia