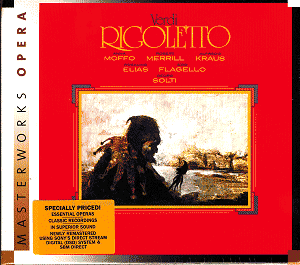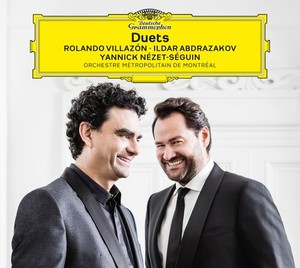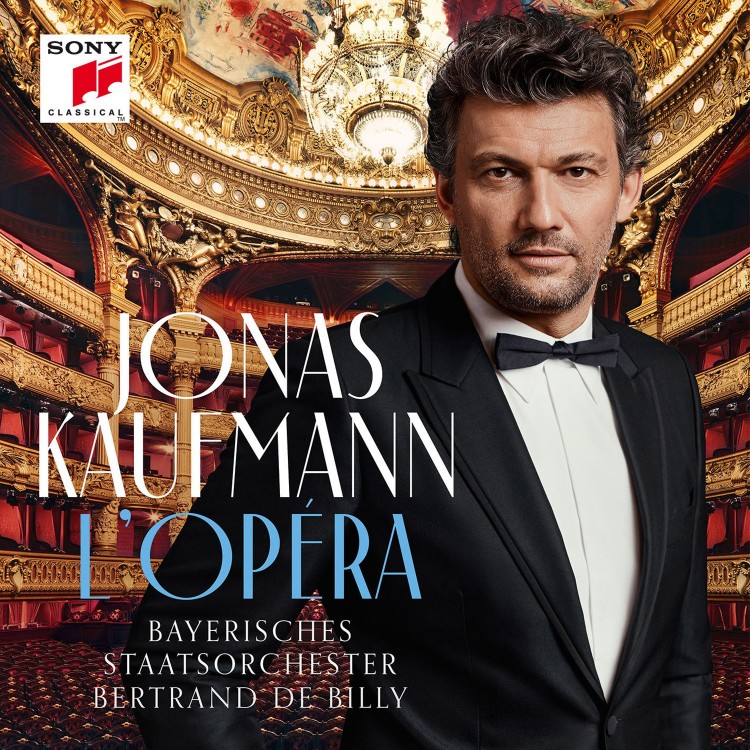Carmen
Aggiunto il 29 Maggio, 2006
Nel salotto di nonna Speranza, quello in cui frughiamo con la certezza di trovare oggetti preziosi di antiquariato, magari da restaurare un po’, si trovano tanti oggetti. Va da sé che alcuni sono carini e possono fare la loro bella figura anche sulla nostra vetrinetta minimalista col vetro acidificato, mentre altre sono deliziosamente kitsch e forse non ci sogneremmo mai di esporle, anche perché la stessa nonna le teneva nel cassetto, forse vergognandosi un po’ di esporle. Magari le terremo in un armadietto non troppo esposto, da andare a guardare solo di tanto in tanto, ma senza sognarci di buttarle perché siamo stati tutti piccoli e tutti abbiamo frugato fra i cassetti della nonna.
Questa registrazione appartiene decisamente alla seconda categoria, e nessuno si sognerebbe di farne bella mostra fra i propri dischi, se non fosse che – effettivamente – è lo specchio fedele di un’epoca che fu, e che oggi proprio è definitivamente scomparsa anche dai ricordi. E poi, via, qualche motivo di interesse oggettivamente c’è.
Pur nella rabbia che mi aveva suscitato la scelta editoriale della Emi per l’allestimento della Carmen della coppia Gheorghiu – Alagna, nessun dubbio che l’interpretazione offertane meritasse la massima considerazione, vuoi per il carisma degli interpreti scesi in campo, vuoi perché – pur costretti negli stretti ambiti di una Choudens/Guiraud – i nostri eroi cercavano di trarne il massimo possibile fruendo di tutto ciò che in questi anni è maturato nella storia dell’interpretazione di quest’opera.
Ma qui, be’, siamo proprio da tutt’altra parte; siamo persino lontani dalla registrazione della Ponselle di cui abbiamo già parlato, in gran parte per colpa della lingua e delle pastoie cui è costretto il direttore, quasi esclusivamente per motivi tecnici.
Devo dire che il buon Sabajno fa del suo meglio per dare una certa traccia interpretativa, pur ristretto dal necessario obbligo di servitù nei confronti dei cantanti, e dai limiti imposti dalle facciate dei 78 giri per cui questa registrazione fu approntata. D’altra parte, non è un mistero che questo direttore, così come l’altro Maestro che con lui spartì le registrazioni effettuate con gli organi della Scala – mi riferisco a Molajoli – fosse un fior di direttore di repertorio, assolutamente padrone della materia, dotato di ottima familiarità con i cantanti che accompagnava e ricco di buon senso.
Ma l’opera, già mutilata dalla versione Choudens e snaturata dai recitativi di Guiraud, è per di più tagliatissima in più o meno tutti i brani, e se c’è un’opera di cui proprio non si dovrebbe perdere nemmeno una nota, è proprio questa. Pazienza. Tal dei tempi era il costume, e non erano epoche che si prestavano ad un recupero filologico del testo scritto, bensì ad un’immediatezza espressiva che rendesse il prodotto immediatamente riconoscibile e, possibilmente, smerciabile. Già, c’era il problema dei 78 giri: tanti dischi, tantissimi, per farci star dentro un’opera intera: già così, come l’ascoltiamo adesso, era decisamente una roba da ricchi.
E poi, la lingua: si tratta infatti di una registrazione in italiano. L’incisione venne chiaramente effettuata per il mercato nazionale e la celebre traduzione di Achille De Lauzières era l’unica possibilità di divulgare quest’opera. Io non ho preclusioni contro le traduzioni; penso infatti che una delle più godibili interpretazioni dei Maestri Cantori che abbia mai sentito sia quella diretta da Matacic con Taddei e Infantino. Ma non c’è dubbio che “Amor lo sappia il mio bel damo” al posto di “Amour est énfant de bohème” ci faccia anche prosodicamente una ben misera figura. Sarebbero tantissimi gli esempi da fare, ma tutto sommato non è un mistero per nessuno che questa sia forse la traduzione in italiano di un’opera straniera peggio riuscita. Il massacro di De Lauzières fu anche il mio primo approccio con questo capolavoro: ero piccolo, e acquistai in edicola un disco di selezione di brani scelti tratti da un’esecuzione dal vivo in cui cantavano Irina Arkhipova, Mario Del Monaco, Marcella Pobbe e Ernest Blanc. Il cast non era male, tutto sommato. Ma ricordo – come fosse ieri – la netta sensazione di trovarmi di fronte ad un’opera completamente diversa allorquando mi misurai con la registrazione DG di Abbado…
Quanto ai cantanti, be’, decisamente non siamo dalle parti delle vette esecutive di ogni tempo. Però…
Gabriella Besanzoni studiò all’Accademia di Santa Cecilia in Roma dove ebbe come insegnanti Alessandro Maggi e Ibilda Brizzi (“Carneade! Chi era costui?”). Anche se non abbiamo notizie sicurissime n merito, fece il suo debutto Viterbo nel 1911 come Adalgisa, e verosimilmente nella tonalità originaria di soprano. Invece, grazie al suo ampio registro medio e alla risonanza delle note basse, decise di reimpostare la propria voce e debuttò come mezzosoprano al Teatro Costanzi di Roma nel 1913 nei panni di Ulrica. Ebbe molto successo alla Scala come Orfeo e Amneris e, nel 1932, come Carmen e Mignon. Fra il 1910 e il 1920 fu un’autentica star del Colón di Buenos Aires e in altri teatri sudamericani. Fra i suoi personaggi più famosi ricordiamo Dalila, Carmen, Amneris, Lola, La Cieca, Preziosilla, Marina, Leonora della donizettiana Favorita, Mignon, Adalgisa, Isabella in L’Italiana in Algeri, senza dimenticare i ruoli mezzosopranili nelle prime performances della Francesca da Rimini di Zandonai e di Jacquerie di Marinuzzi. La cantante apparve anche al Met con Caruso nella stagione 1919/20, ma sembra che non ebbe grande successo. Carmen fu indiscutibilmente il ruolo della sua vita e fu quello con cui si congedò dalle scene nel 1939 alle Terme di Caracalla a Roma nel 1939. Morì nel 1962; dopo il ritiro dalle scene si era dedicata all’insegnamento.
È indiscutibilmente lei la star della registrazione, e il fatto che ricorra (come costumava a quei tempi, ma anche – diciamocelo – in parte ai giorni nostri) a risatacce, rubati e effetti di bassa lega, non toglie un ette ad una prestazione che è ricca di carisma, fascino e, direi, anche di notevole ortodossia vocale. Rispetto alla prestazione vocale della quasi coeva Ponselle ci troviamo di fronte ad una professionista forse meno mediatica, che però canta una vera Carmen. Certo, non la Carmen che conosciamo oggi, bensì la Carmen di quell’epoca: tagliatissima, italiana, estroversa, solare. Ma, insomma, la canta. Tra l’altro, oltre ad una non disprezzabile Habanera e ad una dignitosissima Seguidilla, c’è una scena delle carte ricca di pathos e molto introversa, che si lascia ascoltare con più di un fremito di emozione. E il duetto finale è veramente incandescente. Certamente non siamo ancora di fronte alla definizione completa di un personaggio che dovrà aspettare altre interpreti e – direi – altri spartiti più aggiornati, per affermarsi con completezza. Ma per quello che c’era a disposizione all’epoca, ce n’è abbastanza per capire come mai Carmen fosse il personaggio con cui la Besanzoni avesse scelto di identificarsi.
Maria Carboni propone una Micaela piuttosto adulta, il cui eloquio risuona di personaggi di ben altra caratura. Gli estremi acuti sono piuttosto invadenti (sospetto principalmente per colpa di una microfonazione abbastanza ancestrale) e il suo “Io dico no, non son paurosa” porta abbastanza vicino alla lesione dei timpani. Però, data l’epoca che prediligeva per questo personaggio virginee fanciulline in fiore, doveva essere una discreta novità.
Non ho trovato notizie interessanti su Piero Pauli, che compita un José di buona espansione lirica anche se chiaramente soggiogato dalla protagonista. Il fiore viene chiaramente risolto con l’acuto e non col pianissimo, ma è una nota ben emessa. La traduzione penalizza forse lui più di tutti gli altri interpreti, ed è forse la necessità di rimpolpare con maggiore estroversione una parte piuttosto linfatica è la ragione per cui i José cantati in italiano tendono a virare più dalle parti di Canio e di Turiddu. Pauli resiste lodevolmente a questa tentazione, e mi sembra un titolo di merito non da poco.
Parimenti a me sconosciuto è l’altro Besanzoni, vale a dire Ernesto, di cui non so se l’omonimia sia in qualche modo correlata ad un grado di parentela con la più famosa Gabriella. Voce relativamente chiara, il che di per sé non sarebbe un male, ma personaggio ben poco carismatico, che sembra continuamente chiedere scusa di esserci, e questo sì invece che è un male non da poco. Non lascia nessuna traccia anche se, tutto sommato, non fa grossi danni. Anonimo.
Vale la pena oggi ascoltare una Carmen così? Secondo me, sì. Non è un “Amarcord” perché non c’eravamo, ma è uno spunto di riflessione sul percorso dell’interpretazione e sui punti fermi che, più o meno involontariamente, siamo tentati di mettere allorquando ci imbattiamo in cantanti sulla cui immortalità saremmo disposti a scommettere qualunque cifra. Gabriella Besanzoni ha rappresentato un punto fermo nella storia interpretativa di Carmen degli Anni Trenta. Eppure oggi siamo alla Ewing. E la Besanzoni, con la sua rosa in bocca, ci guarda col suo sorriso seducente da un quadro polveroso nella penombra del salotto di Nonna Speranza.