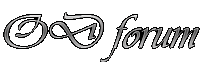DottorMalatesta ha scritto:Il solo punto sul quale volevo insistere è quello per cui in un testo teatrale la maggior o minore compiutezza deve necessariamente fare i conti con la prassi. Prassi che era ed è, nei confronti del testo teatrale, più o meno elastica (e che dipendeva dalle convenzioni, dal pubblico, dalle volontà dell´autore, dall´hic et nunc della rappresentazione). Mi domando se la prassi di oggi, nella riproposizione attuale di un testo del passato, possa/debba tener conto della prassi del passato. Esemplificando, se in epoca barocca le convenzioni prevedevano più possibilità o comunque maggiori libertà esecutive, forse questo potrebbe comportare maggiori libertà anche agli interpreti di oggi.
Secondo me è un falso problema, nel senso che la prassi di un'epoca ha un suo valore intrinseco nell'aiutarci a comprendere la fruizione di un testo, ma con la consapevolezza che tale modalità esecutiva dipendesse da circostanze esterne. Se dovessimo dire "stravolgiamo tutto oggi perché anche allora si stravolgeva" (e quindi senza storicizzare tale approccio) commetteremmo un arbitrio perché oggi le condizioni sono mutate e mutate sono le aspettative e l'atteggiamento del pubblico (senza contare che allora gli interventi servivano a facilitare il pubblico o gli interpreti o soddisfare i desideri di determinati divi, mentre certi interventi odierni - come quello di questo Tell - mi paiono più volti a soddisfare il solipsismo del dramaturg/regista nell'ansia di "farlo strano" piuttosto che per esigenze di natura pratica: non si tratta di alleggerimenti a fronte di interpreti inadeguati, ma di stravolgimenti gratuiti). Ci sono dei limiti, nello spettacolo musicale, più rigidi rispetto ad altri generi teatrali (anche se è pur vero che quando si mette in scena un classico - Shakespeare, Goldoni, Moliere - si tende a sfrondare, ma non a stravolgere).
DottorMalatesta ha scritto:Qualche anno fa al ROF Dario Fo riscrisse per la Gazetta dei dialoghi completamente nuovi (penso fosse per colmare una lacuna dovuta alla mancanza di alcuni numeri della partitura, or non ricordo bene): la cosa poteva avere un senso? Forse sì, bisognerebbe valutare. La “riscrittura” del Viaggio a Reims da parte dello stesso Dario Fo poteva avere senso? Gossett ne parla a lungo nel suo libro, insieme con altri esempi, e giustifica tale soluzione in una prospettiva di pratica teatrale (avrei bisogno di rileggermelo).
Ancora una volta si tratta di questioni differenti: un conto è colmare una lacuna testuale (è il caso della Gazzetta, anche se dal 2012 musica e testo sono stati fortunosamente ritrovati) altro è intervenire pesantemente sul senso dell'opera. Fo, infatti, cambiando il testo del Viaggio a Reims, trasforma la cantata celebrativa dell'incoronazione di Carlo X in un pedante vademecum di perbenismo politico (con le conseguenti tirate contro il capitalismo, la chiesa, l'oppressione del terzo mondo, il colonialismo etc..) che oltre ad appesantire la satira rossiniana (perché il Viaggio a Reims è anche una sottile, ma spietata satira sulla restaurazione), interviene goffamente sui versi a discapito della coerenza musicale (che salta in "medaglie incomparabili" ad esempio). Anche in ottica di pratica teatrale non mi sembra un intervento lecito poiché non parte dal testo (per estrapolarne un suo contenuto), ma prescinde dallo stesso e lo sostituisce con una propria elucubrazione (fuori luogo a mio giudizio).
DottorMalatesta ha scritto:Non si può non tenere conto del qui ed ora, nella riproposizione sul palcoscenico di un testo teatrale.
Ma la pratica teatrale non può rinunciare al confronto col testo, nel senso che forse sarebbe più comodo non avere vincoli, ma proprio perché il teatro musicale è costituito da convenzioni (banalmente: invece di parlare cantano, cantano mentre vengono uccisi o mentre brindano...l'opera è di per sé non realistica) il compito dell'interprete è valorizzare i limiti presenti: altrimenti ha sbagliato mestiere.
DottorMalatesta ha scritto:Il Verdi tagliuzzato di Gavazzeni era il Verdi ritenuto "giusto" allora. Ma non è il Verdi ritenuto "giusto" oggi. E probabilmente non è neppure il Verdi nel quale si riconoscerebbe Verdi stesso!
Può essere, ma resta il fatto che lo stesso Verdi (e Donizetti pure) deprecava manomissioni tagli, aggiusti: è noto che facesse firmare clausole vincolanti con i committenti, con previsione di forti penali e la minaccia di cause e risarcimenti... Certo con scarso successo, ma resta il fatto che l'autore non aveva certo benedetto i tagli di allora, così come sicuramente non avrebbe approvato quelli di Gavazzeni o Serafin.
DottorMalatesta ha scritto:[...]oggi nessuno si sdegna nel sentire Casta Diva o la Ballata di Senta abbassata di un tono [...]
E questo è un problema: un problema di formazione e maturità musicale (e, se posso fare l'antipatico, il risultato di una cattiva educazione e preparazione che ha ridotto l'opera a circo o a concerti per primadonna, così che a teatro non si va a sentire musica, ma ad ascoltare i capricci di un divo). La disinvoltura con cui si abbassa e si alza la tonalità di un brano è sintomo di ignoranza e non tiene conto della complessità del tutto e della sua coerenza armonica (quando poi - come quasi sempre - la ragione di questi trasporti è il consentire grida belluine, acuti piazzati nei posti più impensabili, finti DO di petto, il tutto in barba alla scrittura e solo per soddisfare la pancia dei loggioni o il loro cronometro da acuto - come raccontano con crassa e ignorante soddisfazione i loggionisti parmigiani - allora siamo al becero più totale). Anche perché il SOL maggiore di Casta Diva ha una luminosità che il FA maggiore di tradizione non possiede (tralascio poi il problema degli accompagnamenti o i pasticci combinati nei concertati dove alcuni alzano altri abbassano secondo terze maggiori e minori creando dissonanze e difficoltà nello strumentale: spesso modificato perché richiederebbe note che quello strumento non può emettere).
DottorMalatesta ha scritto: [...] nessuno sbuca dal nulla. Anche il fulmine di Rossini non è un fulmine a ciel sereno. Ma, anche se rischia di far dimenticare che il cielo è pieno di nuvole, un fulmine resta sempre un fulmine!
Ma senza temporale, non c'è nessun fulmine... Non posso non pensare - ad esempio - che l'Amen di Dresda nel preludio di Parsifal è armonizzato più o meno nello stesso modo in cui viene utilizzato dal "giudeo" Mendelssohn (bersaglio polemico dell'antisemitismo wagneriano) nella sua "Lobgesang", op. 52 (la Sinfonia n. 2), che risale a circa 40 prima dell'estremo capolavoro di Wagner.
 . E se il fine giustifica i mezzi, passi pure se qualche convenzione non è stata rispettata. Ma questa è una mia idea, e non voglio convincere nessuno!
. E se il fine giustifica i mezzi, passi pure se qualche convenzione non è stata rispettata. Ma questa è una mia idea, e non voglio convincere nessuno! 
 .
.