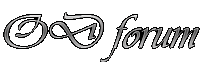da vivelaboheme » lun 09 dic 2013, 13:23
da vivelaboheme » lun 09 dic 2013, 13:23
Letto Bagnoli, apprezzo, in parte condivido in parte no ma questo è bello e normale, ma ne apprezzo, appunto, la civiltà dell'espressione, laddove attorno a questa Traviata, in teatro e sul solito Corriere della Sera ormai avvinto nella sua bega da cortile con il teatro, c'è stata tanta, autentica inciviltà, spesso strumentale, di espressioni. E dico la mia.
Il caso ha voluto che, pochi giorni prima di assistere a questa sconvolgente, rivoluzionaria, miliare Traviata firmata da Daniele Gatti, Dmitri Tcherniakov e Diana Damrau, vedessi l’ultimo – pure sconvolgente film di Woody Allen, Blue Jasmine. In entrambi i casi ( e con una curiosa identità di colore fondamentale: il giallo nei salotti di Allen e in quelli di Tcherniakov), si assiste all’alienazione, annullamento ma in un certo senso glorificazione della protagonista rispetto ad un prossimo che , per insensibilità o convenzione sociale, la “aliena” fino ad una dissociazione dell’anima (Allen) o all’irrigidimento in una morte che non è tanto “tisi” del corpo, quanto dello spirito (l’annunciata “fine sulla sedia” nello spettacolo di Tcherniakov). Un’alienazione che, in Traviata, è annullamento del desiderio-possibilità-bisogno di dare e ricevere amore. Questo è il sopruso, pazzesco, commesso ai danni di Violetta. Respinta a morte più ancora che consunta dal morbo, ma anche elevata dal mondo che l’ha respinta (ecco i famosi violini un’ottava sopra nel finale).
E’ una tematica che trova lancinante espressione musicale nella sconvolgente lettura di Daniele Gatti, che entra in Traviata, la sviscera , l’analizza la ricompone, la vive con quella pazzesca volontà reaizzata di confronto in prima persona con i testi che ne fa un unicum fra i direttori viventi. Chiedersi se sia lento o veloce a mio avviso non ha molto senso, e in presentazione lo stesso direttore aveva dato spiegazioni in merito. Gatti entra in ogni parola, stato d’animo, situazione, trovandoil colore, la dinamica, la scansione, il tempo che non è uno ma sono mille, tanti quanti i moti dell’anima di ognuno dei personaggi, messi in un continuo dialogo, fatto di fremiti e sospensioni, silenzi o urlo o sussurro (estremi: il filo indescrivibile di suono e voce nell’Addio del Passato o la furiosa strappata dei bassi nella cabaletta di Alfredo). E questo pazzesco lavoro “dentro” il testo avviene senza che per un solo istante vada persa la visione sintetica del tutto. Gatti “è” in Traviata nel particolare e nel tutto, l’uno totalmente funzionale all’altro. Mai, e davvero mai, abbiamo ascoltato Traviata così lancinante, disperata: il finale in particolare, tirato allo spasimo (fino al nero e al peso “tragico” di quegli ultimi accordi, cadenzati e battuti dalle memorabili percussioni scaligere) toccava quella corda di consunzione dell’anima nella tragedia che era di certi momenti musicali dell’ultimo, immenso Bernstein (uno dei direttori cui certi aspetti di Gatti da sempre rimandano). Ma, costruita su un suono volta a volta leggerissimo o denso secondo necessità, è una Traviata che – come lo stesso Gatti aveva preannunciato – non ha modelli o precedenti. In qualche modo, ma forse anche oltre, Gatti “si pone”, da direttore, alla maniera con cui Maria Callas si pose da interprete della protagonista. Dirompente rispetto a modelli o passato, ma totalmente pertinente nonché di straordinaria personalità musicale e direi, drammaturgica: è, di per se stessa, una direzione-regia. Grandissimo Daniele Gatti.
La regia c’è: e non si capisce perché e per cosa ancora il pubblico della prima si scandalizzi, a fronte di una lettura linearissima fondata sul dialogo fra le parti, i personaggi: per cui, se Alfredo nell’atto “casalingo” dapprima tira affettuosamente la pasta davanti all’amata, poi taglia furiosamente le verdure davanti alle falsità consolatorie paterne, questo è soltanto l’espressione di ciò che sta avvenendo nella sua anima in dialogo con l’interlocutore, e non c’è proprio niente di scandaloso, è tutto perfettamente naturale, nel quadro d’uno spettacolo nel quale non una sola azione dei personaggi è stata studiata a caso o senza motivo. In questo senso è impressionante tutta l’allucinata seconda festa, con la partita a carte (qui Damrau ha avuto un umanissimo incidente, che ha poi raccontato: è caduta entrando in scena, forse con istantaneo malessere, ecco il perché dello sfasamento in scena: sono esseri umani, al contrario di parte del pubblico) che Gatti conclude dando al concertato una tinta e un carattere "scuri", disperati: è già presagio di morte:finale secondo e finale terzo si specchiano.
Diana Damrau (cui, nota a parte, Tcherniakov mette "accanto" la "presenza", per me azzeccatissima, della Annina quasi-punk della Zampieri) è una meravigliosa Violetta nella quale le doti della virtuosa (non solo le agilità, ma la capacità di assottigliare la voce fino al sussurro, di scurirla o schiarirla, di cantare "sulla parola") vengono messe a totale servizio della realizzazione drammaturgica del personaggio: questa Violetta la cui "tisi" non è – ripetiamo – tanto malattia fisica quanto alienazione dello spirito (i farmaci dell'ultimo atto). Una Violetta che tenta fino all'ultimo (bellissimo l'"Alfredo Alfredo" seduta, provando a spiegare all'amato furioso, impressionante l'irrigidimento finale) di entrare in dialogo con due persone – padre e figlio – o forse un mondo, che non riusciranno a capirla (o non vorranno), e dai quali si alienerà. Nella gestualità dell'ultimo atto (magnifico, qui, Tcherniakov) i due mondi – padre più figlio, e Violetta – si separano completamente, come vi forse un muro invisibile. Violetta non compie movimento o atti "da tisica": sono gli atti di una creatura costretta ad alienarsi (è la sua morte, rigida sulla sedia) da un mondo che non si è sintonizzato con lei. Straordinaria Damrau, ma bravissimi tutti (l'Alfredo volutamente "grossier" – Gatti l'aveva predetto – di Beczala, il cinico papà Germont di Lucic), insieme ad orchestra e coro nell'adesione al disegno complessivo, d'una Traviata contestata dagli irriducibili dell'opera-museo, i papà Germont della Scala, convenzionali tali quali, ma applaudita da chi "ascolta" e "guarda" e partecipa con l'anima. Per noi, una Traviata memorabile, da rivedere e riascoltare (e da portare nel mondo) nella straordinaria direzione musicale e nella forza scenica.
marco vizzardelli
 ?
?