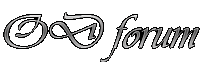Riccardo ha scritto:Questa storia insegna che la "legge" dei creatori va comunque vista con un po' di flessibilità, no?
Caro Ric,
ecco cosa scrivevo io il 7 novembre del 2008, proprio su questo forum (ho messo in grassetto la parte importante).
Ci sono legami tra un interprete e un personaggio che trascendono le "note" scritte e che si imprimono nel sottotesto, in una trama complessa e articolata di relazioni, rimandi, evocazioni.
Sono più difficili da decifrare, ma forse anche più importanti delle note stesse.
Tutto questo, naturalmente, è valido solo nel caso di primi interpreti famosissimi (o per lo meno profondamente noti al compositore, nel momento in cui scriveva per loro); primi interpreti scelti indipendentemente dalla volontà dell'autore non interessano a questa dinamica.
Che ne dici? Avevo o non avevo dato prova di flessibilità?

Proprio la questione della Schumann-Heink in Clitennestra, come ti dicevo, era stata oggetto di un dibattito molto acceso su Operadisc, alcuni anni fa.
E in quel dibattito ero proprio io a negare che vi fosse un rapporto stringente, in questo caso, fra prima interprete e personaggio, in polemica con altri che invece invocavano (proprio sulla scorta della Schumann-Heink) un ritorno a Clitennestre non dico belcantistiche, ma certamente "vocalistiche".
Credo anche io che la flessibilità (come in tutte le cose) sia importante.
O per lo meno... (hai perfettamente ragione) non è tanto una questione di flessibilità, quanto di approfondimento.
Applicare in modo bruto le caratteristiche del creatore agli interpreti attuali non è tanto una "mancanza di flessibilità", quanto una mancanza di "approfondimento".
E' infatti ovvio che non basta.
Nell'analisi del primo interprete vanno considerate tante cose.
1) il compositore e il librettista sapevano - mentre creavano un personaggio - chi sarebbe poi stato il creatore? (certamente Strauss, quando ideò l'Elektra, non aveva idea di chi avrebbero scritturato a Dresda; al contrario Rossini sapeva benissimo che la primadonna a Napoli sarebbe stata la Colbran).
2) e se anche lo conscevano di nome, erano a conoscenza delle sue caratteristiche? (Strauss aveva conosciuto la Schumann-Heink, fra l'altro di stanza nella Bayreuth di Cosima, ma almeno dieci anni prima... non credo poi che ne acquistasse i dischi, considerate le scelte discografiche della Heink. In compenso, come dicevamo tempo fa, nemmeno Rossini conosceva direttamente Garcia quando concepì il suo Norfolk).
3) infine, ammesso che conoscessero benissimo il futuro creatore e il suo "quid" tecnico-poetico, erano sempre in grado di valorizzarli? (questa ultima considerazione non è mia, ma di Beckmesser, e va tenuta a sua volta in grande considerazione: il caso più clamoroso resta quello di Bellini, costretto a modificare - a prove in corso - la tonalità di Casta Diva. E ... se non conosceva la Pasta lui!

).
Tutti questi aspetti vanno tenuti in conto.
Senza di loro una ricerca sul primo interprete non ha molto senso: se bastasse guardare su Wikipedia chi ha creato cosa, allora tutti sarebbero capaci di farlo!

Non è questione di "flessibilità", ma di qualità della ricerca.
E tuttavia, secondo me, nemmeno nel caso peggiore (quando ai tre punti sopra esposti si dovesse sempre rispondere "no") sarebbe giustificata la non considerazione di chi fu il creatore.
In questo panorama, infatti, agisce un'altra figura rilevante: chi ha fatto la "prima" scrittura.
Colui che - con un nuovo spartito davanti - ha dovuto impostare una relazione con gli artisti o le tipologie di artisti di moda al momento.
A fare la "ur-scrittura" poteva essere il direttore d'orchestra, il direttore artistico di un teatro, o talvolta lo stesso compositore (Wagner stesso scritturò i creatori del Ring, anche se - nel quarto di secolo in cui ha composto l'opera - non aveva la più vaga idea di chi l'avrebbe effettivamente creata).
In questo "primo pensiero" di chi ha dovuto far corrispondere un ruolo a un cantante o a una tipologia si svelano già tanti, tantissimi elementi che non possiamo trascurare, se vogliamo davvero comprendere questo strano, affascinante fenomeno (tanto trascurato dalla ricerca, ma tanto centrale nel successo di un'opera, ieri come oggi).
Quindi anche l'errore (se così vogliamo considerarlo) di chiamare una vecchia super-star vocalista come la Schumann Heink, portabandiera del Wagner internazionale (e diva del Met) per creare Clitennestra, può rivelarci tanto cose.
Alla peggio ...anche sull'inconciliabilità tra questa scrittura e un cantante come lei (se si fosse considerata la cosa, ad esempio, non si sarebbe chiamata per questa parte una Ludwig).
Certo è chiaro che è con il tardo Ottocento-Novecento che la composizione inizia a rendersi talvolta indipendente dalle immediate richieste della rappresentazione.
Rossini, al posto di Strauss, avrebbe scritto ben altrimenti la parte di Clitennestra avendo in cartellone a Dresda simile cantante. Senza per questo esitare a rivoluzionarne la scrittura in un secondo tempo per la Bahr Mildemburg.
Non credere Ric...
Anche nel '900 i rapporti fra scrittura e primo interprete erano fortissimi.
Pensa solo a Britten... con lui è quasi assurdo parlare di tenori, soprani, mezzosoprani.
Sarebbe quasi più semplice limitarsi a dire "ruoli-Pears", "ruoli-Cross", "ruoli-Vyvian", "ruoli-Ferrier"....
E Strauss? I ruoli Jeritza! I ruoli Lehmann... o per l'appunto i ruoli Siems.
Ho come l'impressione, da questa vicenda straussiana, che ad un certo punto si siano invertiti i ruoli. La forza prescrittiva e rivoluzionaria rispetto alla scrittura musicale del compositore che avevano i cantanti, più tardi è diventata a volte prerogativa del compositore. Non potrebbe essere che Strauss abbia "inventato" un nuovo modo di cantare con la sua rivoluzionaria scrittura vocale per Clitennestra, invece di registrare l'esistente come divinamente sapevano fare i grandi operisti italiani del primo Ottocento (e non solo, naturalmente)?
Bellissima domanda, Ric!

Io sinceramente non la vedo così.
Prendi Giuseppe Verdi.
Lui scrisse il Nabucco per la Strepponi (e penso che possiamo dire che la conoscesse bene), eppure la Strepponi vi si strangolò.
Fu definito, Verdi, Attila delle voci, nel senso che la sua scrittura si rivelò faticosissima per gli interpreti allora attivi. Le cose migliorarono solo quando - a posteriori - nacquero i primi cantanti "specializzati" sulle novità di Verdi.
Ma possiamo davvero affermare che Verdi fosse del tutto avulso dalle tipologie dei cantanti a lui immediatamente precedenti?
Non direi... semmai (sull'onda della sua personalità) egli aveva esasperato certe caratteristiche. Aveva preso i grandi soprani rabbiosi del secondo donizetti (il modello Ronzi, poi surrogato da quello Ungher, Barbieri Nini e appunto Strepponi) e li aveva resi ancora più rabbiosi, ne aveva portato un linguaggio a un tale livello da parossismo che a un certo punto i modelli originari non bastarono più e si dovette andare oltre.
E non di meno, per affermare tutto questo, noi dobbiamo pur sempre sapere che tipo di cantanti erano queste Barbieri-Nini, queste Ungher e queste Strepponi.
Idem per Wagner: la tendenza a esasperare la parola a danno del vocalismo strumentale era già in atto ai tempi di Wagner (un caso per tutti? la seconda Viardot).
Wagner si appoggiò a questo tipo di esperienza, prese il via da essa e la esasperò al punto che, per tenergli dietro, sono dovuti nascere cantanti specializzati, a costo di rinunciare al vocalismo (proprio come i primi veri verdiani specialisti dovettero rinunciare al belcantismo pirotecnico di Rossini).
Anche in questo caso se non conosci le caratteristiche dei cantanti da cui Wagner trasse ispirazione e di quei primi interpreti dei quali fu più soddisfatto (Caronsfield e la Materna ad esempio, che guarda caso nel repertorio tradizionale non erano un granché) non ti rendi davvero conto di tanti piccoli elementi che possono far luce su certi aspetti della sua scrittura.
Sono finito su questo argomento proprio perché di recente riflettevo un po' sulla Siems, prima Zerbinetta (della prima versione tra l'altro!) dopo (!) aver creato Chrysothemis e la Marescialla. Tutto nel giro di pochi anni.
Ve le immaginate la Gruberova (o la Dessay) al cimento in queste parti, certo non declamatorie, ma tuttavia almeno apparentemente un po' diverse?

[/quote]
Il caso della Siems, per altro grandissima artista, è molto interessante.
Era una cantante estesa nel sopracuto e formidabile nella coloratura.
Tutto il contrario (a parte Zerbinetta) delle cantanti a cui oggi affidiamo i ruoli scritti da Strauss per lei.
E tuttavia ti faccio osservare che a Dresda era allora attiva un'altra straordinaria cantante di coloratura (una leggendaria Norma e Semiramide, per altro; un'incredibile Marguerite di Valois): ossia Irene Abendroth.
Noterai che la Abendroth mai fu chiamata per un ruolo straussiano (men che meno Zerbinetta), mentre la Siems sì.
Come mai?
Evidentemente (e i dischi lo confermano) la Siems non era "solo" un soprano di coloratura.
In lei agiva anche un'attrazione per il canto "nuovo", la valorizzazione della parola, l'accensione dei primi veri colori declamatori, che la rendeva plausibile per le grandi creazioni straussiane.
Nè si può pensare che Strauss trascurasse, in lei, l'altra componente: quella più tradizionale, virtuosa, vocalistica.
Tutto questo forse non era chiaro già dalla prima volta: ossia Crisotemide.
Era la prima volta che Strauss collaborava con lei e probabilmente la conosceva poco (ovviamente la Siems non aveva preso parte alla prima di Salome, per cui era stata chiamata una totale declamatrice come la Wittich, già Isolde a Bayreuth).
Inoltre, come abbiamo detto per la Schumann-Heink, Strauss cominciò a comporre Eletra senza avere un'idea precisa di chi sarebbe stato scritturato nella creazione.
Infatti la parte di Crisotemide è, sì, un po' più acuta di quella di Elektra (ma non come estensione: Elektra arriva più in alto, toccando il do), è sì più lirica, sì più melodica, ma ancora priva di quelle particolarità inconfondibili (tipicamente "Siems") che troveremo nelle due tipicissime creazioni successive.
Marescialla e Zerbinetta.
Su Zerbinetta (prima versione) inutile insistere: tutti ne vediamo l'insolita vocazione sopracuta, il virtuosismo spettacolare, ecc...
Su Marescialla il problema è più delicato, perchè (ovviamente, dato il personaggio) non vi sono nè sopracuti, nè agilità.
E' per questa ragione che il personaggio è presto passato nelle mani dei sopranoni, spesso persino corti in acuto (la grande Lehmann ad esempio).
Eppure a ben guardare la parte è un florilegio di mezzetinte, di colori iridescenti, di sussurri algebrici che rivelano proprio quella singolare commistione di vocalismo "contaminato" che è la più impressionante caratteristica della Siems (oltre all'intelligenza, l'ironia in punta di forchetta, il fascino diafano e moderno).
La rivoluzione della Schwarzkopf in questo ruolo (che all'epoca scandalizzò i tradizionalisti, proprio per la "leggerezza" vaporosa del suo canto, a sua volta a metà fra retaggi vocalistici, filature estatiche e lavorio sulla parola) fu a ben guardare un'opera di "filologia"

Non è un caso che la Schwarzkopf fosse stata anche Zerbinetta!
Che begli argomenti, Ric. Aspetto le tue repliche.
Salutoni,
Mat