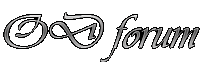Eccomi qua.
Come promesso tenterò un'analisi comparativa dei due brani, rivolta non solo agli amici del forum, ma anche agli occasionali lettori.
Perché il gioco funzioni, consiglio al lettore di tenere aperte contemporaneamente anche le due pagine “audio” dove sono contenuti i brani,
Gencer – Gui:
http://www.operadisc.com/audio3.php?id=195Verrett – Abbado :
http://www.operadisc.com/audio3.php?id=196regolare i volumi in modo che siano (grossomodo) corrispondenti e agire sulla pausa in modo da sentire uno dopo l’altro i singoli frammenti.
Pronti?
Bene... partiam!
LADY
Regna il sonno su tutti... Oh qual lamento
risponde il gufo al suo lugubre addio!
MACBETH (di dentro)
Chi v'ha?
LADY
Ch'ei fosse di letargo uscito
pria del colpo mortal?
Macbeth stravolto con un pugnale in mano.
MACBETH
Tutto è finito!Iniziamo con Gencer.
Entra in scena come avvolta da un alone di mistero.
L'effetto è ottenuto piazzando la voce molto in alto nella maschera: lo sentite benissimo nella “o” di sonno e nella “u” di tutti, particolarmente risonanti.
Come al suo solito, una lieve sottolineatura esalta ogni sillaba (“r”egna il “s”onno su “tu”tti) in modo che, nonostante il suono sussurrato e sospeso, la frase ha una scansione netta.
Già da questa prima frase notate come la Gencer usi il ritmo con una consapevolezza da grande musicista: per tutto il brano questo sarà uno dei suoi segreti.
La frase successiva “Oh qual lamento” è a sua volta sussurrata, ma rapida, più aggressiva. C’è un tocco di fragilità spaesata nel suo canto (grande idea) che si ritrova perfettamente all’attacco della frase successiva: “Risponde il gufo al suo lugubre addio” . La Gencer parte quasi dolce per poi incupirsi a partire da “gufo” (sottolineato da un piccolo “colpo di glottide”) e precipitare con determinazione fonda su “addio” (la volontà riprende il sopravvento sulla paura).
“Chi va?” chiede Taddei, e la Gencer, si getta nella frase successiva “ch’ei fosse di letargo uscito” con una precipitazione scomposta, staccando le sillabe sempre in pianissimo ma con un vero fremito di paura.
Peccato solo che, nella tensione, sbagli le parole (“pria del colpo mortal).
Cose che dal vivo capitano.
“Tutto è finito” sussurra Taddei.
Bene, bene. Ora fate STOP e passiamo ad Abbado.
“Regna il sonno su tutti” è detto dalla Verrete abbastanza bene; non c’è la sospensione magica (perché manca la proiezione “alta” della Gencer) ma l’effetto del pianissimo corroso è comunque funzionante.
Poi però con “ah, qual lamento” cominciano i problemi.
L’”Ah” è troppo caricato. Anche “qual lamento” è pronunciato con un’enfasi eccessiva, che mette fra l’altro in evidenza la pessima articolazione italiana.
Imparagonabile è anche la frase “risponde il gufo al suo lugubre addio” in cui la Gencer aveva scalato un arco emozionale più vasto (smarrimento, tensione, determinazione). La Verrett dispone di minori risorse dinamiche e cromatiche, quindi la prima parte della frase è senza tensione; si scalda solo alla fine “lugubre” e “addio” .
“Chi va?” chiede Cappuccilli.
Anche la Verrett, come la Gencer, vorrebbe avventarsi con precipitazione nella sua risposta “ch’ei fosse di letargo uscito” ; ma il difficile rapporto con la lingua italiana le impone un tempo più lento e un’articolazione più circospetta. Il risultato è molto meno brillante.
“Tutto è finito” sussurra Cappuccilli.
E noi andiamo avanti.
MACBETH
Fatal mia donna! Un murmure,
com'io, non intendesti?
LADY
Del gufo udii lo stridere...
Testé che mai dicesti?
MACBETH
Io!
LADY
Dianzi udirti parvemi.
MACBETH
Mentre io scendea?
LADY
Sì!
MACBETH
Di'! Nella stanza attigua
chi dorme?
LADY
Il regal figlio...
MACBETH (guardandosi le mani)
O vista, o vista orribile!
LADY
Storna da questo il ciglio...
MACBETH
O vista orribile! O vista orribile!Gui e Abbado staccano praticamente lo stesso tempo e anche l’intensità degli archi è simile.
La Gencer, come sempre, è interprete rifinitissima, che ragiona su ogni frase. Ce ne accorgiamo subito, quando - alla domanda di Macbeth “un murmure non intendesti?” - risponde con un tono che contrasta profondamente con quello di Taddei.
Freddo, tagliente, sempre in mezzoforte, perentorio con un'ombra di sufficienza e risentimento.
“del gufo udii lo stridere! Testè che mai dicesti?”.
Stesso effetto.
Lui (Taddei) si affanna in pianissimi e sussulti, lei ferma, altera, mascella dura. La sua voce non cambia colore, né intensità.
“dianzi udirvi parvemi” “il regal figlio”…
Solo il “sì” pare caricarsi involontariamente di una lievissima tensione (c’è paura anche in lei o semplicemente non è più in grado di frenare l’irritazione?).
Poi Macbeth si rivela: “O vista, o vista orribile!” urla con fin troppa enfasi Taddei.
Ma la Gencer tiene duro: anche “storna da questo il ciglio” ha lo stesso colore freddo, ma stavolta non è più possibile negare il sarcasmo (sentite cos’è il colore di quello “storna”).
Ora fate stop e torniamo ad Abbado.
Dopo la Gencer, sentire la povera Verrett arrancare in “del gufo udii lo stridere! Testé che mai dicesti” fa quasi tenerezza.
Non è solo la difficoltà della lingua a colpire, ma la genericità dell’accento , la retorica da teatrino di paese.
Per nulla aiutata da Abbado, bisogna essere sinceri, la Verrett non trova di meglio che esibire un tono acido e insinuante da “cattivaccia” che non solo non è originale (quanto lo era stata la Gencer) ma nemmeno credibile.
E se lo porterà dietro per tutto il duetto (anzi, ahimè, per tutta l'opera).
Personalmente l’immagine che mi evoca questo biascicamento a occhietti stretti è la strega in qualche recita natalizia per bambini.
La VErrett inoltre è estremamente limitata in termini di colori e chiaroscuri (vitali in Verdi); qualche volta ci si prova, come ad esempio nella frase “dianzi udirti parvemi”. Ma poi ricasca nei suoi zoppiccamenti di pronuncia e nel piglio da strega per bambini: il "sì" (pur non essendo brutto) è sibiliato alla sir Biss.
“Il regal figlio” e “storna da questo il ciglio” sono detti e cantati un po’ meglio, con una sensazione di palpitazione, ma si ha sempre l’idea di un’eccessiva uniformità di colori e di effetti.
Andiamo avanti.
MACBETH
Nel sonno udii che oravano
i cortigiani, e Dio
sempre ne assista, ei dissero;
amen dir volli anch'io,
ma la parola indocile
gelò su' labbri miei.
LADY
Follie!
MACBETH
Perché ripetere
quell'amen non potei?
LADY
Follie, follie che sperdono
ai primi rai del dì. Torniamo a Gui.
Lasciamo che Taddei faccia la sua tirata; per inciso è molto convincente (grazie all’abile, farneticante dinamica).
La Gencer commenta (sempre fredda e distante) il suo ripetuto “follie”.
Ma attenti! Aguzzate le orecchie perché sta per arrivare uno di quegli attimi di genio da cui dipende un’interpretazione.
Dopo che Taddei ha detto “quell’amen non potei”, Gui e Gencer fanno una cosa imprevista. Con un'intesa assolutamente perfetta, caricano il ritmo, lo sbalzano di sinistra volgarità paesana (zùm pà pà, zum pà pà).
Su questo rapidissimo valzer di morte la Gencer si mette a piroettare, fluorescente e leggera come una ballerina.
Sentite con quanta precisione stacca il ritmo (“foll-ì-e, foll-ì-e”), come ghermisce leggermente i tempi forti (“che *spèr*dono), come cristallizza il favoloso arpeggio (alla ripetizione di “follie”), facendo della sua voce un perfetto e sinistro carillon.
C’è da restare stupefatti. L'idea non è solo originalissima (nessuno nella discografia esegue in questo modo quel passo) ma grandiosamente realizzata. Pochi secondi appena, ma siamo nel genio...
Bene, ora schiacciate pausa e torniamo ad Abbado.
Il confronto è semplicemente demoralizzante.
Intanto Cappuccilli è a sua volta molto meno persuasivo di Taddei, anche perché Abbado lo spinge sulla pessima idea di accentare a piena voce le frasi dei cortigiani (Nel sonno udii che oravano i cortigiani: “E Dio..”).
Non solo è una soluzione un po’ sciocca, da calligrafismo gratuito, ma Cappuccilli non è l’interprete giusto per sfoggi di dialettica.
Ma torniamo alla Verrett: i primi due “follie” non sono male: sempre un po’ sovraccarichi, ma almeno “colorati” (tensione, agitazione, paura).
Purtroppo ben modesto è il “follie, follie che sperdono i primi rai del dì”.
Ora, io non pretendo che la Verrett e Abbado rinnovino il colpo di genio della Gencer e di Gui, inventandosi anche loro qualcosa di strano e sconvolgente. Ma quella che ci propongono non ha davvero niente che vada oltre una banale lettura: la Verrett poi non potrebbe seguire il direttore in giochi ritmici e dinamici particolari, perché è già abbastanza in difficoltà tecniche; l'arpeggio è praticamente un portamento...
non parliamo dei soliti orrori di pronuncia (folie)
Ok, ok, in fondo era americana!"
Ma la Gencer non era forse turca?
E i preparatori di Palermo sono tanto più bravi di quelli della Scala o della deutsche Grammophon?
Bah… procediamo.
MACBETH
Allor questa voce m'intesi nel petto:
avrai per guanciali sol vepri, o Macbetto!
Il sonno per sempre, Glamis, uccidesti!
Non v'è che vigilia, Caudore, per te!
LADY
Ma, dimmi, altra voce non parti d'udire?
Sei vano, o Macbetto, ma privo d'ardire;
Glamis, a mezz'opra vacilli, t'arresti,
fanciul vanitoso, Caudore, tu se'.
MACBETH
Vendetta! Tuonarmi, com'angeli d'ira,
udrò di Duncano le sante virtù.
LADY
(Quell'animo trema, combatte, delira...
Chi mai lo direbbe l'invitto che fu!)Taddei si lascia andare a un'enfasi eccessiva.
Ma a noi è la Gencer che interessa.
“Ma dimmi altra voce non parti d’udire”.
Finalmente un po’ di umanità si insinua nel suo canto.
Il suono è appena più liquido e il legato più “comprensivo”.
Poi comincia la progressione (vocale e psicologica) delle frasi successive.
“Sei vano, Macbetto, ma privo d’ardire” è già più intenso, ma resta un mezzoforte, appena ombreggiato di dolcezza. Il “d’ardire” è quasi civettuolo (appena, appena).
Ma sentite il ritmo: la frase è tenuta saldamente in pugno, preceduta dall’incisiva anacrusi (Sei-vano).
L’intensità cresce con la frase successiva “Glamis a mezz’opra vacilli, t’arresti”.
“mezz’opra” “vacilli” sono sottolineate con un piglio più scandito.
L’approdo alla frase successiva “fanciul vanitoso, Caudore, tu sei” è a voce spiegata, ma sempre con quel distacco freddo, di chi si impone la calma, di chi schiaccia dentro di sé l’ombra del disprezzo.
In compenso sentite cosa combina la nostra quando parla fra sé e sé:
“Quell’animo trema, combatte, delira. Chi mai lo direbbe l’invitto che fu!”
La voce si fa espressiva, ma il colore è nuovamente opalescente (suoni alti), e la precisione ritmica torna a farsi sostanza psicologica.
Il sottile disprezzo (un filo divertito) si accentua nello splendore dei mordenti su “delira”, “mai” “direbbe”.
Solo “invitto” (alla fine) assume un colore davvero sprezzante.
Tutto il resto del duetto è praticamente tenuto in piedi (ritmicamente) dalla Gencer, che procede con tale perfezione insieme agli archi da lasciare di stucco. Sembra che diriga lei.
E' questa tensione ritmica che ci costringe a restare attenti e coinvolti fino alla fine, mentre - come vedremo - con Abbado e la Verrett dopo un po ci si annoia.
Fermo restando che Cappuccilli continua a sembrarmi generico e impacciato, la Verrett parte, occorre ammetterlo, benissimo con “ma dimmi altra voce non parti d’udire”?
Non che comunichi molto, ma la frase è tenuta con sibillina sottigliezza e si risolve (splendidamente) in un “d’udire” puntuto, sottile e molto allusivo.
Poi purtroppo si ritorna subito nella prosa: a parte i brutti effetti gravi di “sei vano” “vacilli”, tutta la frase, nella sua sognante e stralunata stabilità, è distrutta da una serie di sottolineature a singulto, non solo dozzinali, ma soprattutto anti-verdiane (sei và-nò-mà; d’ardì-hìre, glamis-hà-mèz-zò).
Ma niente in confronto della bruttura di “quell’animo trema”.
Peccato perché qui Abbado, finalmente, tira fuori le unghie del raffinato concertatore (con quei colpetti d’arco simili a punture di spillo), ma la Verrett stacca le note con l'impaccio e il disagio di una studentessa, e il risultato è uno spappolamento miserando di tutta la frase!
Inoltre non c’è un cambiamento di colore, un gioco dinamico, un’intenzione che riveli un disegno psicologico.
Non si vede l’ora che il brano finisca…
fortunamente, sulle ultime battute, la Verrett si riscatta con un interessante “chi lo direbbe, chi lo direbbe, l’invitto che fu”, dove si fa largo qualche colore sinistro e convincente, ma ancora una volta senza lontanamente avvicinarsi alla vellutata ambiguità della Gencer.
Bah…. Procediamo.
LADY
Il pugnal là riportate...
Le sue guardie insanguinate...
che l'accusa in lor ricada.
MACBETH
Io colà?... Non posso entrar!
LADY
Dammi il ferro.
MACBETH
Ogni rumore mi spaventa!
Oh questa mano!
Non potrebbe l'oceano
queste mani a me lavar! Per la prima volta, la Gencer tira fuori tutta la sua rabbia per l'inerzia del marito.
Ancora una volta l’adesione ritmica è perfetta; notare l’evidenza dell’affondo nel registro di petto (“là riportàte”).
E’ tale lo sdegno che, alla frase “Dammi il ferro!”, la Gencer perde il controllo e su “ferro” commette un passo falso.
Questo è l’unico punto in cui l’edizione di Abbado mi pare superiore.
La secchezza categorica dell’accompagnamento di Abbado è travolgente.
Anche la Verrett pare a suo agio e risponde bene alla sollecitazione.
Ma avviamoci al finale, perché anche qui ci sarà una grossa sorpresa!
 LADY
LADY
Vedi! Le mani ho lorde anch'io;
poco spruzzo, e monde son.
L'opra anch'essa andrà in oblio...
MACBETH
Odi tu? Raddoppia il suon!
LADY
Vien!
Vieni altrove! Ogni sospetto
rimoviam dall'uccisor;
torna in te! Fa' cor, Macbetto,
non ti vinca un vil timor.
MACBETH
Deh potessi il mio delitto
dalla mente cancellar!
Deh, sapessi, o re trafitto,
l'alto sonno a te spezzar!La Gencer entra - come sempre - perfetta sui ritmi, con piglio fermo, deciso e “professionale” (notare l’evidenza ritmico di “oblì-ò).
Poi… ancora il genio.
“Vien”… la Gencer sfodera su questa parola (appena ghermita a mezza voce) il suo strepitoso registro misto, ambrato di voluttà!
Una parola che ne dice diecimila: c’è l’urgenza di nascondersi dell’assassina che sta per essere scoperta, ma c'è anche l’imperiosità dolce, a fior di labbra, della moglie che sa come trascinarsi dietro il marito.
Una parola che vale quanto un’aria.
Ma non è ancora niente.
Quel che segue è ancora più straordinario.
“Vieni altrove e ogni sospetto rimoviam dall’uccisore”
Soprano e direttore ingranano la marcia e partono verso le vette dell’arte verdiana.
Tempo rapidissimo, leggerissimo, agilissimo, in cui il soprano si muove con la sicurezza di un’atleta, si avvinghia alle parole (sentite le s di “uccisore”, le r di “fa cor”), ne assapora il suono, si scaglia sul ritmo con improvviso sussulti (fa cor macbet-TO).
E ancora una volta, uscendo di scena e calandosi nell’ombra, quegli arpeggi fluttuanti come un velo, tutti perfettamente incastonati nel ritmo affannoso della stretta.
Ecco, questo è dominare
da dentro l’opera italiana, il respirare con lei.
Ciò che, mi spiace, né Abbado, né la Verrett possono fare.
Nella stretta Abbado stacca un tempo sbagliato, non solo perché è lento, ma perché è legnoso, schematico, senza alcun respiro interno, che rende triviale la melodia.
Dov'è andata l'agitazione aerea di Gui, la nevrotica leggerezza...
Non è questione di “suono” (che anzi ai violini della Scala scappano alcuni effetti niente male) quanto di respiro interno.
Per colpa anche di Abbado, la povera Verrett è qui semplicemente ridicola: evoca una anziana signora a cui salta in mente di cantare, a una festa, una canzonetta popolare di quando era bambina.
Ecco le mie impressioni.
Salutoni,
Mat