Rodrigo ha scritto:Condivido l'osservazione, comune a vari critici, che il lessico dell'Otello sia - in qualche modo - "nato vecchio". Si poteva osare di più nel modernizzare la lingua del melodramma e Boito aveva i prerequisiti per farlo,. E invece tira fuori il balteo, gli oricalchi il Dio ti giocondi e altre nefandezze. Tralascio, infine, il noto giudizio limitativo di Riccardo Bacchelli (!) sulla costruzione del personaggio di Jago. Invece il quadro del palazzo degli Abati nel Boccanegra mi piace molto..
Caro stimolantissimo Rodrigo,
partiamo dal primo punto,.
Quello che tu consideri un difetto a me pare inveceil pregio del libretto di Otello e, cosa anche più importante, il segno di una perfetta intesa, almeno tra compositore e librettista.
E' tanto che sostengo che Otello è l'Opera della "memoria", l'opera che guarda al passato, all'Operismo romantico che ha già chiuso la sua stagione.
In quest'ottica rientra il vecchio discorso (qui a lungo trattato) della vera vocalità del protagonista: Tamagno era un reazionario del vocalismo, uno fra gli ultimi esemplari del modello Duprez-Tamberlick, un tenore che lucidava gli argenti di antiche armature mentre il mondo faceva a pezzi il Romanticismo o quel che ne rimaneva).
Nella sua fase "verdiana", Boito colse e amò proprio questo aspetto dell'ultimo Verdi, questo culto della "santa memoria" (e dei dardi fulgenti) che - a quel punto - era divenuto anche per lui, per Boito, più importante di tutte le utopie rivoluzionarie della gioventù, negli anni (relativamente brevi) della sua adesione alla Scapigliatura.
In quest'ottica l'utilizzo di arcaismi e citazioni ultra-classiche non è un limite, ma una scelta.
Così come l'etereità "stilnovistica" di Desdemona.
Sono tutti i segni che in quest'opera nè Boito, nè Verdi volevano arrendersi al nuovo (come poi si è voluto in tutti i modi far credere) ma che al contrario si inchinavano ...provocatoriamente al vecchio.
...Altro che rinnovare il linguaggio librettistico! L'ha fatto, certo, ma in modo assai più sottile che non nelle forme lessicali.
sul secondo punto... la costruzione di Jago.
Lo Jago di Boito non è lo Jago di Shakespeare. Sono proprio personaggi diversi.
E' una grave colpa?
Io non direi. Anche in questo caso è una scelta.
A Boito non interessava riproporre lo Jago di Shakespeare perché per il Bardo il "cattivo" è un "nullo" (sono ben altri i cattivi shakespeariani); questo è solo un cialtrone, delatore, vigliacco, che in realtà non ha in mano nulla (un fazzoletto?). E' vero che riesce ugualmente a convincere Otello delle proprie menzogne, ma solo perché Otello ne è già convinto, a prescindere: in Shakespeare il razzismo è "in Otello". E' la consapevolezza della sua insanabile diversità a farlo crollare: ...sognare e crollare... un po' come Violetta, Rigoletto, Alvaro e altri "diversi" Verdiani.
Il ruolo di Jago (in Shakespeare) è dunque modesto. Per Boito il fascino di questo cattivo sta da tutt'altra parte.
Diversi anni fa, un conoscente - appassionatissimo e studioso di Boito - mi fece notare che fra le righe di ogni verso boitiano traluce una passione totalizzante per gli ideale massonici ed esoterici. Ogni opera, ogni verso, ogni personaggio descrive a suo modo una contrapposizione "a monte", universale fra bene e male.
Le sue opere sono ricolme di demoni, di veri e propri figli dell'oscurità.
Jago non è che uno dei tanti demoni distruttivi, negatori e disperati che popolano le opere di Boito.
Come quel conoscente mi fece osservare, è solo in quest'ottica che Boito mette in bocca a Jago quell'agghiacciante "credo" al contrario (bestemmia fra le bestemmie) di cui non è traccia in Shakespeare.
Con Boito jago diventa iemissario di una forza oscura e antichissima, pre-storico, pre-umano, la forza del male che agisce nella storia: è la bestia che urla dall'eternità, anche se ben nascosta dietro un caschetto biondo e modi effeminati.
In quest'ottica il personaggio c'è: non sarà quello di Shakespeare (ma in fondo stiamo parlando dell'Otello di Boito e Verdi, non dell'altro), ma è terribilmente riuscito, incisivo, magnificamente descritto.
Resta poi - che ci piaccia o meno - proprio quella qualità di versi (non solo in senso poetico, ma anche "musicale": varietà di accenti, libertà prosodica, fonosimibolismo della parola) che Verdi disperatamente ricercava fin dai tempi dell'Aida.
E poi, vivvaddio, Boito era uno che il senso del teatro lo possedeva davvero.
Come dici tu, Piave era un genio (e anzi per me l'artefice principe della rivoluzione verdiana e io preferisco di gran lunga i suoi libretti a quelli di Boito), ma la scena del consiglio nel Boccanegra si stacca come un'eruzione vulcanica su tutto il resto del libretto.
Teo.Emme ha scritto:Qualche tempo fa vidi a Milano una bella mostra sulla pittura "scapigliata": artisti imbevuti di maledettismo nostrano, sedicenti anticonformisti, contestatori, elaboratori di programmi e manifesti letterari in cui se la prendevano con tutto e tutti (contro la tradizione, contro la società, contro la morale comune etc..), perchè volevano cambiare il mondo! E che era esposto in quelle sale? "Ritratti e ritrattini" da appendere nei salotti della buona borghesia lombarda, sartine alla finestra intente nella lettura, illustrazioni da romanzo d'appendice... Altro che rivoluzione
la grande importanza degli scapigliati non sta nelle loro opere, nella loro "pars costruens" ma nella giustissima denuncia di una situazione che in Italia (non solo in ambito operistico) si era arenata. Nella seconda metà dell'800 il mondo si scatenava in tutte le fecondissime direzioni del post-romanticismo (il realismo attraversava metà dell'Europa, il simbolismo l'atra metà, il mondo cambiava, la società cambiava, l'opera cambiava, la musica cambiava)... Noi invece, tutti tronfi della recente "unificazione nazionale" (anch'essa in ritardo di qualche secolo sulle altre monarchie europee), ce ne stavamo fermi.
Denunciare questo, se non altro alzare polveroni e creare dibattito fu il loro grande merito. Il loro contributo non va cercato nei "quadri" o nelle "poesie" che alcuni di loro scrissero, ma nel dibattito che furono in grado di produrre in tutto il paese (e che ebbe conseguenze vastissime).
E' vero che gli Scapigliati erano soprattutto "combattenti"; e come è noto il limite di chi passa la vita a "combattare per qualcosa" (il loro limite, forse anche il tuo

) è che poi si perde la serenità del giudizio.
Essere guerrieri e obbiettivi contemporaneamente è quasi impossibile...

Quanto all'episodio del Rigoletto, a me pare tutt'altro che assurdo... vuoi mettere con Giovanna d'Arco (che tutti sapevano da secoli essere stata arsa sul rogo) che viene ferita in battaglia, salva il re (quello che l'ha consegnata agli inglesi) e poi muore senza nemmeno bruciacchiarsi un unghia fra cori celesti?
No, niente da fare. Solera batte Piave venti a zero.

Salutoni,
Mat
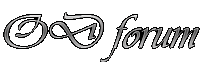
 Non rispondermi nemmeno, ti prego: non lo merito!
Non rispondermi nemmeno, ti prego: non lo merito!