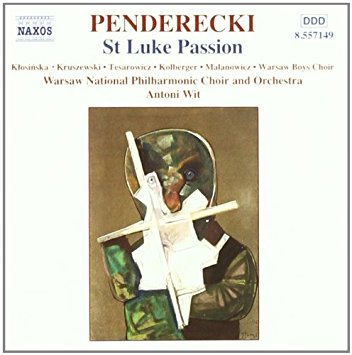Editoriale: Il giallo dell'Incoronazione - di Giuseppe Massimo Culcasi
Aggiunto il 04 Ottobre, 2016
 IL GIALLO DELL’INCORONAZIONE DI POPPEA. E SE IL “COLPEVOLE” FOSSE CAVALLI?
IL GIALLO DELL’INCORONAZIONE DI POPPEA. E SE IL “COLPEVOLE” FOSSE CAVALLI?
Come tutti gli appassionati sanno, la questione relativa all’attribuzione dell’Incoronazione di Poppea è un labirinto a tutt’oggi irrisolto. Districarsi tra le sue spire sonore e poetiche, più che compito del musicologo sarebbe compito del giallista. Perché – diciamocelo chiaro e tondo – la musicologia, almeno per quanto riguarda il ‘600, non ha mai dimostrato di avere i mezzi né le carte in regola né tantomeno la volontà indagatrice per districare nodi così intricati. Per capirci, se si esamina lo stile (o gli stili, per meglio dire) presenti nell’Incoronazione di Poppea, cosa ci riporta a Monteverdi ed alla sua gamma di soluzioni compositive, con particolare riferimento al periodo ultimo della sua esistenza? Di certo non il concitato, che era stata la grande novità di brani universalmente noti come “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda”. Per concitato si intende la ribattuta di sedici semicrome sulla stessa nota, ed è un procedimento il cui “affetto” è collegato all’ira ed allo sdegno: ebbene, nell’Incoronazione di Poppea è presente soltanto una battuta di concitato, nell’atto 1°, sulle parole “allo sdegno” pronunciate da Nerone, troppo poco in un libretto che di occasioni di ira e di sdegno ne offre a iosa. Meno ancora il lamento, che pure non era stato inventato da Monteverdi, che tuttavia ne offrì i due esempi archetipici più elevati nel “Lamento di Arianna” (in stile recitativo) e nel “Lamento della Ninfa” (strofico su tetracordo discendente), e che comunque appare in quasi tutte le opere veneziane antecedenti e successive all’Incoronazione di Poppea, nella quale lo ritroviamo in due occasioni, entrambe nel personaggio di Ottavia, ossia “Disprezzata regina” e “Addio Roma”, lamenti entrambi in stile recitativo. Anche in questo caso nulla di particolarmente riconducibile allo stile di Monteverdi, quanto piuttosto allo stile del primo Cavalli, che offrì esempi
 stilisticamente analoghi di lamenti in stile recitativo in opere antecedenti l’Incoronazione di Poppea, esempi di livello e di intensità affettiva almeno pari a quelli di Ottavia, come nel caso de “Gli amori di Apollo e Dafne” del 1640 (Lamento di Procri) e “Didone” del 1641 (Lamento di Didone). Di certo non riporta a Monteverdi il confronto diretto con “Il Ritorno di Ulisse in Patria” composto l’anno prima, un’opera che deve la sua fama più al prestigio dell’Autore che alle qualità intrinseche, in quanto – pur presentando alcune pagine di elevata fattura – denuncia esplicitamente le difficoltà dell’anziano compositore di fronte a quella grande novità che rappresentava il teatro impresariale ed il rapporto “commerciale” con il pubblico. La carriera operistica di Monteverdi nel periodo antecedente (di cui purtroppo non possediamo documenti scritti se non il prezioso “Orfeo”) si era svolta sempre nel campo dell’opera mecenatesca, con melodrammi eseguiti nelle corti e nei ristretti ambiti dei palazzi nobiliari, e tale genere di opera non rispondeva alle esigenze drammaturgiche e musicali del nuovo pubblico “interclassista” dei teatri a pagamento, quanto piuttosto ad esigenze letterarie e poetiche di carattere elitario. Non a caso Il Ritorno di Ulisse in Patria è opera debolissima sul piano drammaturgico e dell’interazione tra i caratteri, ed appare più la traduzione in musica di un testo letterario che un’opera lirica in senso autentico, mancando di quel contrasto drammatico e psicologico che era già tipico del teatro musicale di quegli anni: basti operare un confronto con la Didone di Cavalli, composta nel medesimo anno 1641, per riscontrare un abisso profondo tra la vitalità del capolavoro cavalliano e la scarsa o assente sostanza drammaturgica dell’opera monteverdiana. E tale abisso appare, altrettanto marcato, nella differenza di spessore musicale, drammaturgico, psicologico tra Il Ritorno di Ulisse in Patria e l’Incoronazione di Poppea.
stilisticamente analoghi di lamenti in stile recitativo in opere antecedenti l’Incoronazione di Poppea, esempi di livello e di intensità affettiva almeno pari a quelli di Ottavia, come nel caso de “Gli amori di Apollo e Dafne” del 1640 (Lamento di Procri) e “Didone” del 1641 (Lamento di Didone). Di certo non riporta a Monteverdi il confronto diretto con “Il Ritorno di Ulisse in Patria” composto l’anno prima, un’opera che deve la sua fama più al prestigio dell’Autore che alle qualità intrinseche, in quanto – pur presentando alcune pagine di elevata fattura – denuncia esplicitamente le difficoltà dell’anziano compositore di fronte a quella grande novità che rappresentava il teatro impresariale ed il rapporto “commerciale” con il pubblico. La carriera operistica di Monteverdi nel periodo antecedente (di cui purtroppo non possediamo documenti scritti se non il prezioso “Orfeo”) si era svolta sempre nel campo dell’opera mecenatesca, con melodrammi eseguiti nelle corti e nei ristretti ambiti dei palazzi nobiliari, e tale genere di opera non rispondeva alle esigenze drammaturgiche e musicali del nuovo pubblico “interclassista” dei teatri a pagamento, quanto piuttosto ad esigenze letterarie e poetiche di carattere elitario. Non a caso Il Ritorno di Ulisse in Patria è opera debolissima sul piano drammaturgico e dell’interazione tra i caratteri, ed appare più la traduzione in musica di un testo letterario che un’opera lirica in senso autentico, mancando di quel contrasto drammatico e psicologico che era già tipico del teatro musicale di quegli anni: basti operare un confronto con la Didone di Cavalli, composta nel medesimo anno 1641, per riscontrare un abisso profondo tra la vitalità del capolavoro cavalliano e la scarsa o assente sostanza drammaturgica dell’opera monteverdiana. E tale abisso appare, altrettanto marcato, nella differenza di spessore musicale, drammaturgico, psicologico tra Il Ritorno di Ulisse in Patria e l’Incoronazione di Poppea.
Possibile dunque che
 un compositore anziano, nell’ultimo anno della sua esistenza, muti improvvisamente registro adeguandosi ai tempi nuovi con uno scarto stilistico così impressionante? Chi sostiene tale tesi cita due esempi apparentemente analoghi: il Rameau di Les Paladins e Les Boreades ed il Verdi di Falstaff. Ma sia nell’uno che nell’altro caso, pur in presenza di sostanziose e geniali innovazioni, la firma di Rameau e di Verdi è riconoscibilissima, non foss’altro che per le frequenti e spesso ironiche autocitazioni. Nell’Incoronazione di Poppea, invece, nulla di tutto questo, nulla che riporti a Monteverdi ed al suo passato.
un compositore anziano, nell’ultimo anno della sua esistenza, muti improvvisamente registro adeguandosi ai tempi nuovi con uno scarto stilistico così impressionante? Chi sostiene tale tesi cita due esempi apparentemente analoghi: il Rameau di Les Paladins e Les Boreades ed il Verdi di Falstaff. Ma sia nell’uno che nell’altro caso, pur in presenza di sostanziose e geniali innovazioni, la firma di Rameau e di Verdi è riconoscibilissima, non foss’altro che per le frequenti e spesso ironiche autocitazioni. Nell’Incoronazione di Poppea, invece, nulla di tutto questo, nulla che riporti a Monteverdi ed al suo passato.
E’ bene allora ricostruire il motivo per cui quest’opera viene da sempre attribuita a Monteverdi. Nello scritto “Minerva al tavolino”, pubblicato dal dalmata Cristoforo Ivanovich, nel 1681 (ossia 39 anni dopo l’esecuzione dell’opera), l’Incoronazione di Poppea viene ascritta, per l’appunto, a Monteverdi. Chi ha contestato apertamente tale attribuzione, come Thomas Walker ed Annibale Gianuario, non ha mancato di far notare i numerosi errori contenuti nel testo di Ivanovich, che d’altra parte era giunto a Venezia nel 1650, ben dopo le due esecuzioni veneziane dell’Incoronazione di Poppea (1643 e 1646), e che sbagliò l’attribuzione di altre 7 opere. A rafforzare l’ipotesi monteverdiana giunse, nel 1993, il ritrovamento da parte di Paolo Fabbri del cosiddetto “manoscritto di Udine”, un libretto dell’opera completo di indicazioni sceniche ed interpretative che riporta l’indicazione dell’autore: Monteverdi, per l’appunto. Ma è decisivo tale ritrovamento? Chiude per sempre la questione? Secondo Ellen Rosand sì, secondo me, molto umilmente, no… e vediamone assieme i motivi.
Ed iniziamo con l’elenco cronologico delle non moltissime opere di cui sappiamo per certo che furono messe in scena a Venezia dal 1637 (apertura del Teatro San Cassiano) fino al 1643, anno della messa in scena dell’Incoronazione di Poppea, corredate dal nome dell’autore delle
 musiche.
musiche.
- Andromeda (Francesco Manelli)
- La Maga Fulminata (Francesco Manelli)
- La Delia (Francesco Manelli)
- L’Armida (Benedetto Ferrari)
- Le Nozze di Peleo e Teti (Francesco Cavalli)
- L’Adone (Francesco Manelli)
- Gli Amori di Apollo e Dafne (Francesco Cavalli)
- Il Pastor Regio (Benedetto Ferrari)
- La Didone (Francesco Cavalli)
- Il Ritorno di Ulisse in Patria (Claudio Monteverdi)
- Le Nozze d’Enea con Lavinia (Claudio Monteverdi)
- La Finta Pazza (Francesco Paolo Sacrati)
- La Ninfa Avara (Benedetto Ferrari)
- La Virtù de’ Strali d’Amore (Francesco Cavalli)
- L’Incoronazione di Poppea (Claudio Monteverdi?)
Di tutte queste opere, fatta eccezione per l’Incoronazione di Poppea, sappiamo per certo sia il librettista che l’autore delle musiche, per la presenza chiara ed esplicita dei rispettivi nominativi nei frontespizi dei libretti o per la presenza, in alcune di esse, di documenti di contorno, quali sonetti celebrativi, lettere, cronache. Da qui nasce, per il giallista, la prima imprescindibile domanda: perché mai in una sola opera su 15 manca il nome del compositore? E, come se non bastasse, perché mancano i documenti di contorno? E, tenuto conto che il Divin Claudio era il compositore all’epoca più prestigioso tra quelli operanti a Venezia, perché mai tacerne l’identità, che sicuramente – in un contesto commerciale come quello del teatro impresariale – sarebbe stato un sicuro richiamo per il pubblico?
Per comprendere le cause dell’anonimato della musica, secondo me dobbiamo dare un’occhiata al libretto del Busenello. Pochi l’hanno sottolineato, ma il libretto dell’Incoronazione di Poppea rappresenta un unicum nella storia dell’opera, almeno fino a tutto il ‘700: è un’opera dove non soltanto vincono i “cattivi”, ma alla fine i “cattivi” vengono celebrati da un grande trionfo… e non soltanto: anche le vittime sono “cattive”. Se Ottavia ed
Ottone sono vittime dell’amore amorale e proibito di Nerone e Poppea, la stessa Ottavia non esita ad ordinare ad Ottone l’assassinio di Poppea, ed Ottone (pur con qualche esitazione) si presta alla congiura. Il solo Seneca appare moralmente condivisibile, ed infatti fa la fine di Socrate. Non esiste il lieto fine, laddove il lieto fine, tipico dei melodrammi barocchi, è sia la realizzazione in terra della giustizia divina sia la vittoria della Ragione, venendo incontro in tal modo sia alle esigenze della morale cristiana che alla nascente ideologia illuminista. La trama di quest’opera ci ricorda pericolosamente alcune produzioni moderne come la serie televisiva di Gomorra, dove tutti i personaggi sono in vario grado criminali e dove il pubblico finisce per identificarsi e parteggiare per l’uno o l’altro di essi. Lo scetticismo etico e la sistematica sospensione del giudizio di Busenello, in quest’occasione ed in questa soltanto, sconfina esplicitamente e senza mezzi termini nell’amoralità, e penso proprio che questa caratteristica fosse evidente (quasi certamente ancor più di adesso) al pubblico ed agli intellettuali contemporanei all’opera. Claudio Monteverdi era sacerdote dal 1632 e maestro di cappella alla Basilica di San Marco dal 1613. Tralasciando le idiosincrasie stilistiche di cui ho già parlato, è possibile che un sacerdote musichi un’opera siffatta? Possibile, certo, ma poco probabile: Monteverdi non era un “prete itinerante” per motivi di autopromozione professionale come in seguito sarebbero stati Cesti e Vivaldi, ma – essendo insediato a San Marco come maestro di cappella – visse i suoi ultimi anni a Venezia in un ambiente ecclesiastico e poco o pochissimo mondano. Inoltre non emergono da alcun documento né tantomeno da alcuna testimonianza dubbi sulla sincerità della sua, pur tardiva, vocazione sacerdotale.
A partire, dunque, dall’amoralità esplicita del libretto di Busenello, possiamo operare una deduzione sul motivo dell’anonimato della  musica: Giovanni Francesco Busenello era avvocato e svolgeva regolarmente la professione forense, non fu un librettista professionista ma occasionale dato che compose soltanto 5 libretti, e la scabrosità etica della trama dell’Incoronazione di Poppea non poteva nuocere alla sua professione. E’ evidente, per quanto tale elemento non sia mai stato sottolineato dalla storiografia musicale, che chi ha composto la musica di tale opera avrebbe potuto subirne ripercussioni negative in termini di carriera: non si spiega altrimenti l’anonimato, e sfido chiunque a ricercarne altri possibili motivi. Ma nella Venezia del XVII secolo, cattolica di sicuro ma non soggetta alle direttive del Papato, chi poteva subire ripercussioni negative da una vicenda siffatta? Due sole persone, entrambe in qualche modo legate alla Basilica di San Marco: il primo è Claudio Monteverdi, che ho escluso per motivi stilistici ed in quanto sacerdote presumibilmente di vocazione sincera, e Francesco Cavalli, che svolse la sua carriera non operistica (prima come cantore, poi come primo organista) sempre a San Marco. Da notare che gli incarichi marciani di Cavalli erano retribuiti in maniera minima se confrontiamo i compensi con gli introiti derivanti dalla produzione di melodrammi e dai possedimenti della ricca consorte, ma erano pur sempre incarichi di elevato prestigio, a cui Cavalli dimostrò sempre di tenere moltissimo.
musica: Giovanni Francesco Busenello era avvocato e svolgeva regolarmente la professione forense, non fu un librettista professionista ma occasionale dato che compose soltanto 5 libretti, e la scabrosità etica della trama dell’Incoronazione di Poppea non poteva nuocere alla sua professione. E’ evidente, per quanto tale elemento non sia mai stato sottolineato dalla storiografia musicale, che chi ha composto la musica di tale opera avrebbe potuto subirne ripercussioni negative in termini di carriera: non si spiega altrimenti l’anonimato, e sfido chiunque a ricercarne altri possibili motivi. Ma nella Venezia del XVII secolo, cattolica di sicuro ma non soggetta alle direttive del Papato, chi poteva subire ripercussioni negative da una vicenda siffatta? Due sole persone, entrambe in qualche modo legate alla Basilica di San Marco: il primo è Claudio Monteverdi, che ho escluso per motivi stilistici ed in quanto sacerdote presumibilmente di vocazione sincera, e Francesco Cavalli, che svolse la sua carriera non operistica (prima come cantore, poi come primo organista) sempre a San Marco. Da notare che gli incarichi marciani di Cavalli erano retribuiti in maniera minima se confrontiamo i compensi con gli introiti derivanti dalla produzione di melodrammi e dai possedimenti della ricca consorte, ma erano pur sempre incarichi di elevato prestigio, a cui Cavalli dimostrò sempre di tenere moltissimo.
Dato che abbiamo evocato il fantasma di Francesco Cavalli, è bene esaminare gli indizi che collegano l’Incoronazione di Poppea alla sua figura. Innanzitutto partiamo dalla figura di Busenello: di lui si sa con certezza che compose 5 libretti, forse 6 se si considera l’Eliogabalo di Cavalli che qualcuno gli attribuisce, quantomeno incompiuto o in forma embrionale, ed esattamente:
- Gli amori di Apollo e Dafne (1640), musicato da Francesco Cavalli
- Didone (1641), musicato da Francesco Cavalli
- L’Incoronazione di Poppea (1643), musicato da Claudio Monteverdi
 (?)
(?)
- La prosperità infelice di Giulio Cesare dittatore (1646), musicato da Francesco Cavalli
- La Statira (1655), musicato da Francesco Cavalli.
Una circostanza a dir poco lampante salta agli occhi: tutti i libretti composti da Busenello, con l’eccezione dell’Incoronazione di Poppea, furono musicati da Cavalli. Busenello il quale, ripeto, non fu mai librettista di professione, operò esclusivamente per Cavalli, con il quale ebbe, con tutta evidenza, un rapporto artistico non privilegiato, ma esclusivo. L’unica eccezione, almeno secondo la storiografia musicale ufficiale, risulterebbe L’Incoronazione di Poppea. Se abbiamo escluso Monteverdi per i motivi sopra esposti, abbiamo un primo indizio che ci riconduce senza ombra di dubbio alla possibile paternità di Cavalli.
Ma andiamo alle due partiture, quella di Venezia e quella di Napoli, le uniche due superstiti dell’Incoronazione di Poppea, entrambe adespote. Tenuto conto che l’intera partitura napoletana è opera di un unico copista e non ci consente di risalire all’autore, pur conservando un grande interesse musicologico e di scelte esecutive nell’analisi delle differenze con quella veneziana, andiamo a guardare da vicino, per l’appunto, la partitura di Venezia: in essa sono riconoscibili ben 7 mani diverse, ma una è riconoscibilissima ed inconfondibile: quella di Maria Sozomeno, moglie di Francesco Cavalli e sua copista, che ha copiato per intero il 1° ed il 3° atto. Nella partitura veneziana lo stesso Cavalli ha introdotto di sua mano numerose correzioni ed aggiunte, in particolare tagli e trasposizioni. Non è il caso né il fine del mio scritto entrare nei dettagli di tali correzioni, per le quali rimando il lettore al saggio di Elen Rosand pubblicato a partire da pag. 119 del volume “Francesco Cavalli – La Circolazione dell’Opera Veneziana nel Seicento” (Turchini Edizioni Napoli, 2005).
Per lo scopo del mio scritto, che è soltanto quello di contribuire alla risoluzione del giallo
 relativo alla paternità dell’Incoronazione di Poppea, è importante, anzi essenziale rifarsi alla prima delle due partiture, quella veneziana, dove l’intervento di Cavalli testimoniato dalla calligrafia della consorte e dalle correzioni operate da Cavalli stesso è ampiamente prevalente. E qui sorge spontanea una domanda: in quali altre occasioni Cavalli ha messo mano in opere non sue? Di sicuro Cavalli è l’operista veneziano del ‘600 riguardo al quale siamo meglio documentati; egli ebbe cura di conservare accuratamente i manoscritti di tutte le sue opere, per cui pochissime sono andate perdute, e la sua notorietà fu tale da consentirci agevolmente di ricostruire la sua carriera con la massima cura e senza dubbi. In conseguenza di ciò la risposta è una ed una sola: Cavalli non rimaneggiò mai alcuna opera che non fosse sua, e fra l’altro non ne avrebbe avuto il motivo, dato che egli era ricco di suo a cagione dell’ingente patrimonio della moglie e la sua carriera operistica fu coronata da un successo tale da non rendere mai necessari lavori “secondari” come il rimaneggiamento di composizioni altrui.
relativo alla paternità dell’Incoronazione di Poppea, è importante, anzi essenziale rifarsi alla prima delle due partiture, quella veneziana, dove l’intervento di Cavalli testimoniato dalla calligrafia della consorte e dalle correzioni operate da Cavalli stesso è ampiamente prevalente. E qui sorge spontanea una domanda: in quali altre occasioni Cavalli ha messo mano in opere non sue? Di sicuro Cavalli è l’operista veneziano del ‘600 riguardo al quale siamo meglio documentati; egli ebbe cura di conservare accuratamente i manoscritti di tutte le sue opere, per cui pochissime sono andate perdute, e la sua notorietà fu tale da consentirci agevolmente di ricostruire la sua carriera con la massima cura e senza dubbi. In conseguenza di ciò la risposta è una ed una sola: Cavalli non rimaneggiò mai alcuna opera che non fosse sua, e fra l’altro non ne avrebbe avuto il motivo, dato che egli era ricco di suo a cagione dell’ingente patrimonio della moglie e la sua carriera operistica fu coronata da un successo tale da non rendere mai necessari lavori “secondari” come il rimaneggiamento di composizioni altrui.
I due indizi che ho esposto (il primo, indiretto, riguardante la produzione librettistica del Busenello ed il secondo, diretto, riguardante la calligrafia della partitura veneziana dell’Incoronazione di Poppea), unitamente al fatto che la sinfonia introduttiva è identica a quella della Doriclea dello stesso Cavalli, ci conducono, con pochissimo margine di dubbio, ad attribuire l’opera a Francesco Cavalli. Se infatti non ci fosse stata l’attribuzione tardiva di Ivanovich, tale attribuzione rivestirebbe quasi certamente il carattere dell’ufficialità.
Rimangono però dei piccoli nodi da risolvere, senza i quali il nostro giallo non sarebbe, per l’appunto, un giallo.
Una prima domanda che sorge spontanea è la seguente: Cavalli ebbe cura di conservare accuratamente e di autoattribuirsi tutte le opere che compose: perché mai ciò non avvenne conL’Incoronazione di Poppea? La questione riguarda, a mio parere, il carattere scabroso, amorale e tendenzialmente ateistico del libretto: Cavalli non era un sacerdote come lo era stato Monteverdi, ma rivestiva pur sempre un importante incarico nella Basilica di San Marco. Firmare la musica di un siffatto libretto avrebbe cozzato quasi certamente con tale incarico, e la carriera prestigiosa del Cavalli organista avrebbe subito contraccolpi.
Un’altra questione aperta riguarda l’eterogeneità compositiva dell’opera: fra i casi più controversi c’è ad esempio, il duetto finale (“pur ti miro”), che potrebbe essere di Cavalli, ma anche di Benedetto Ferrari, dato che il testo è contenuto nel “Pastor Regio” dello stesso Ferrari; inoltre parecchie sezioni del finale dell’opera sono identiche ad alcune sezioni dell’opera “La Finta Pazza” di Sacrati. Al di là del fatto che il problema della paternità artistica e dei diritti d’autore era sentito nel ‘600 in maniera molto diversa che nella nostra epoca, è molto probabile che l’Incoronazione di Poppea, presentata in forma anonima sin dalla prima rappresentazione, abbia subito nel corso degli anni e delle varie esecuzioni, numerose modifiche ed apporti, per cui alla fine risulta un’opera composta a più mani, ma la cui traccia prevalente ed originaria sarebbe quella di Cavalli.
Ultima questione è quella del cosiddetto “manoscritto di Udine” rinvenuto nel 1993, una trascrizione del libretto che riporta il nome di Monteverdi come autore. Secondo me tale attribuzione, mai riportata ufficialmente e trascritta quasi di straforo su un libretto “ufficioso” (ossia non a stampa, quindi non destinato al pubblico pagante) è la testimonianza di una sorta di scelta di comodo, forse alimentata dallo stesso Cavalli: quella di attribuire, seppure non ufficialmente, l’opera a chi era già morto e quindi non avrebbe mai pagato il prezzo di una scelta scomoda, quella di aver musicato un testo profondamente amorale ed in contrasto con leideologie dominanti. Il “manoscritto di Udine”, quindi, non sarebbe per me utile ad attribuire l’opera a Monteverdi, quanto piuttosto a scagionare Ivanovich, che non avrebbe inventato una paternità farlocca, ma l’avrebbe semplicemente ereditata dalla vulgata corrente.
Vorrei infine, giusto per completare il quadro, sgomberare il campo da un’ipotesi che di tanto in tanto viene avanzata per giustificare l’eterogeneità stilistica dell’opera, e che ai miei occhi appare tra le più assurde. E’ la questione della cosiddetta “opera di bottega”, ossia l’idea secondo la quale l’Incoronazione di Poppea sarebbe stata composta da Monteverdi con l’ausilio secondario ed ancillare dei vari Cavalli, Ferrari, Sacrati. Nella prima metà del ‘600, è bene saperlo, non esistevano “opere di bottega”: si trattava di un’epoca nella quale non esisteva quasi distinzione tra recitativo ed aria, ed anzi il recitativo era la struttura portante del nascente melodramma, per cui non accadeva – come al tempo di Mozart – che il compositore affidasse i recitativi ad un allievo o collaboratore per occuparsi delle arie. In secondo luogo è totalmente impensabile che Cavalli, Ferrari o Sacrati, che all’epoca avevano circa 40 anni ed erano ben affermati, svolgessero il compito di “garzoni di bottega” dell’anziano Monteverdi.
In conclusione: per quanto si tratti di indizi, tutto ci porta – a mio parere – ad attribuire l’Incoronazione di Poppea, o almeno la maggior parte di essa, a Francesco Cavalli. Io, da adesso in avanti, quando ne parlerò, la attribuirò a lui. La musicologia ufficiale continuerà ad attribuirla a Monteverdi più per abitudine che sulla base di elementi concreti, ma il tempo (e concedetemi questa piccola presunzione…) mi darà ragione. In fondo, fino ad una cinquantina d’anni fa, tutti eravamo convinti che su Marte ci fossero i canali, e lo si studiava anche a scuola, o – tanto per rimanere sulla musica – fino ad una ventina d’anni fa, tutti credevano che la Missa Salisburgensisdi Biber fosse di Orazio Benevoli, morto dieci anni prima della sua composizione.
Giuseppe Massimo Culcasi